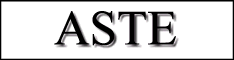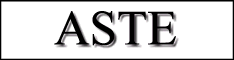|
MARCO
CATALANO
Magistrato
del Tribunale di Torre Annunziata
LA
REVOCATORIA FALLIMENTARE
Brevi cenni al sistema fallimentare.
La qualifica del curatore, se terzo o parte.
Il sistema di tutela apprestato dal legislatore del 1942 (sezione
III della legge fallimentare).
I sui rapporti con l' azione revocatoria ordinaria ex art.
2901 c.c.. Concorrenza dei due rimedi.
L' azione revocatoria fallimentare ex art. 67.
I casi di revocatoria previsti dall' art. 67 l.f..
Ogni moderno sistema giuridico necessita di una legge fallimentare
che si ponga come rimedio alle crisi che può subire
il singolo imprenditore nell' esercizio della sua attività
di impresa ; come si sa per definizione l' attività
imprenditoriale è frutto di un rischio, più
o meno calcolato da colui che la intraprende. Nel caso in
cui, vuoi per circostanze interne vuoi per incapacità
imprenditoriale l' imprenditore commerciale si trova in stato
di insolvenza, esso è assoggettato al fallimento.
Le due principali attività da compiere nel corso della
procedura fallimentare costituiscono l' accertamento del passivo
e la liquidazione dell' attivo al fine di permettere l' equo
soddisfacimento dei creditori.
Tra le attività volte alla ricerca e liquidazione dell'
attivo, lato sensu, rientrano quelle poste in essere dal curatore
al fine di reintegrare il patrimonio del fallito depauperato
nell' imminenza (o successivamente) alla dichiarazione di
fallimento.
In questa ottica si inseriscono le norme di cui agli artt.
64 e ss. l.f. dedicate alla disciplina degli effetti del fallimento
sugli atti pregiudizievoli ai creditori.
Attore nei giudizi instaurati in base elle citate norme è
il curatore, rappresentato e difeso da un avvocato iscritto
all' albo, a tanto autorizzato dal g.d..
Circa la qualifica del curatore nei giudizi di revocatoria
fallimentare, ovvero se sia terzo o parte, dopo lungo dibattito
la dottrina e la giurisprudenza uniformemente propendono per
la qualifica di terzo. Invero numerose norme della legge fallimentare
prevedono la successione del curatore nei rapporti giuridici
in precedenza in capo al fallito. Mi riferisco primis all'
art. 31 comma 1 l.f. il quale stabilisce che il curatore ha
l' amministrazione del patrimonio fallimentare, e alle varie
norme che attribuiscono al curatore la potestà di dare
corso o meno ai contratti stipulati dal fallito in bonis,
disciplinate dagli artt. 72 e ss l.f..
Poiché però l' azione revocatoria da un lato
tende a dichiarare efficace un contratto o un atto già
posto in essere e perfetto, dall' altro mira a recuperare
nell' interesse dei creditori un bene già facente parte
del patrimonio fallimentare, e poiché l' attività
del curatore lede l' interesse di chi ha acquistato o comunque
ricevuto legittimamente dei beni, unanimemente ormai si qualifica
il curatore come terzo rispetto alle azioni che pone in essere
; la questione non è di poco conto per le sue conseguenze
processuali ; se infatti si considera il curatore terzo allo
stesso, ad esempio, non potrà essere deferito interrogatorio
formale.
Dottrina e giurisprudenza oramai unaninemente concordano nell'
attribuire al curatore la veste di terzo nell' esercizio delle
azioni revocatorie. Circa l' ulteriore problema della qualifica
di terzo, ovvero se sostituto processuale o di rappresentante
dei creditori, o titolare di autonomo diritto, si propende
per la terza ipotesi, in virtù delle caratteristiche
pubblicistiche che connotano la disciplina fallimentare. Si
tratta infatti di un istituto mirato al soddisfacimento, per
quanto possibile, delle ragioni creditorie ed al terzo curatore,
in questo interesse, è riconosciuta la possibilità
di agire in giudizio ; diverso è invece il caso, per
esempio, in cui il curatore agisce o resiste in giudizio in
relazione ad una pretesa azionata dal o contro il fallito
prima della dichiarazione di fallimento, in cui farà
valere il singolo diritto del fallito qualora lo ritenga utile
per la massa dei creditori.
Occorre per l' agire o resistere in giudizio l' autorizzazione
del g. d, resa con decreto, generalmente in calce alla istanza
o alla nota o relazione con la quale il curatore avrà
rappresentato al g.d. la necessità di agire in giudizio
; l' autorizzazione del g.d. è valida solo per l' azione
indicata dal curatore ; sebbene al riguardo non rilevi il
nomen juris dallo stesso attribuito in quanto sia il procuratore
della curatela, sia il giudice nel corso della controversia
possono cambiare denominazione all' azione, sempre che non
muti la rappresentazione del fatto. L' autorizzazione, per
giurisprudenza unanime vale sono per il grado di giudizio
conferita e non è sufficiente per l' esperimento delle
azioni cautelari che si rendono necessarie in concorrenza
con il diritto fatto valere ; ciò per la peculiarità
della tutela cautelare che presenta caratteristiche e presupporti
di fatto diversi per il suo utile esperimento.
Per quanto riguarda in particolare le caratteristiche delle
azioni a tutela (rectius volte alla ricostruzione) del patrimonio
del fallito, il legislatore del 1942 ha previsto una serie
numerosa di ipotesi, tutte comunque in concorrenza con il
criterio generale previsto dagli artt. 2901 e ss c.c. dettati
in tema di revocatoria ordinaria.
La caratteristica principale delle azioni a tutela del fallimento
è l' utilità generale che se ne ricava ; mentre
l' esercizio dell' azione revocatoria ordinaria comporta utilità
per il solo creditore procedente, il quale può poi
coattivamente soddisfarsi sul bene alienato dal debitore al
terzo, le azioni revocatorie fallimentari permettono l' accrescimento
delle attività fallimentari a tutto giovamento della
massa dei creditori ; non è un caso infatti che nell'
art. 2901 c.c. si indichi al singolare il creditore, mentre
gli artt. 64 e ss. l.f. parlano di inefficacia nei confronti
dei creditori.
Nulla osta comunque alla concorrenza dei due rimedi o all'
utilizzo di uno al posto del' altro, laddove, per esempio,
è decorso il termine di prescrizione per l' azione
revocatoria fallimentare, in questo caso però il curatore
dovrà assolvere agli oneri probatori previsti dall'
art. 2901 c.c.. Infine potrà esservi il caso in cui
un creditore abbia, precedentemente alla dichiarazione di
fallimento, iniziato uti singulus un' azione revocatoria ;
in questo caso, stante anche il divieto di cui all' art. 51
l.f. , egli non potrà più utilmente proseguirla
; pertanto spetterà al curatore decidere se proseguire
il giudizio, questa volta però nell' interesse dalla
massa o abbandonarlo ; in quest' ultimo caso, infine, una
volta chiuso il fallimento, il creditore riprenderà
la titolarità della sua azione nei confronti del debitore.
Competente a conoscere dell' azione revocatoria è il
tribunale fallimentare, ovvero il tribunale che ha dichiarato
il fallimento dell' imprenditore, a mente dell' art. 24 l.f..
Detta regola è di carattere assoluto e non trova eccezioni.
Pertanto, nel caso di tribunale diviso in più sezioni,
competente a conoscere delle cause di revocatoria è
la sezione fallimentare del tribunale ; detto principio trova
ingresso anche con l' adozione del nuovo rito civile, che
ha previsto la composizione del tribunale quale giudice unico
; infatti non trova applicazione 48 ord. giud. il quale stabilisce
i casi in cui il tribunale decide in funzione collegiale ;
la riserva di collegialità è stata dettata solo
per i giudizio di fallimento, opposizione al fallimento, omologazione
di concordato preventivo e in quelli di cui agli artt. 98,
100 e 101 l.f..
Il sistema delineato negli articoli che la l.f. dedica all'
azione revocatoria è stato concepito dal legislatore
secondo scansioni e presunzioni ; le scansioni riguardano
il dato temporale di compimento dell' atto rispetto alla sentenza
dichiarativa di fallimento, le presunzioni hanno ad oggetto
l' onere della prova che si atteggia diversamente a seconda
degli atti da revocare. E' bene precisare che il termine a
ritroso del quale vanno computati gli atti inizia con la data
del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento ; nessun
rilievo riveste la data di deliberazione in camera di consiglio
o quella di comunicazione della sentenza o quella di affissione
della stessa. Da questo punto di vista quello che rileva è
il fallimento il quale secondo la legge e la giurisprudenza
dominante, è assistito da una presunzione relativa
di conoscenza che si atteggia in concreto diversamente a seconda
degli atti da revocare.
E' naturale che i presupposti per l' azione revocatoria siano
diversi a seconda che si tratti di azione revocatoria ordinaria
o fallimentare ; nel primo caso ci si trova innanzi ad un
soggetto che ha alienato il bene allo scopo di frodare, ovvero
rendere privo di garanzia il suo creditore ; l' alienazione
assume in questo caso un aspetto patologico, mentre per l'
imprenditore commerciale l' alienazione, l' acquisto, la successiva
alienazione di beni costituisce lo strumento normale per l'
esercizio della sua attività ; si pensi ai frequenti
casi di costituzione di garanzie sui beni anche personali
dell' imprenditore al fine di ottenere erogazione di prestiti
o somme di danaro, o credito nel mercato ; in questo caso,
considerando l' alienazione o comunque la cessione di bene
un aspetto fisiologico dell' esercizio dell' impresa, il legislatore
ha voluto ancorare i presupposti per l' esercizio dell' azione
revocatoria a dati di fatto oggettivi conosciuti o comunque
conoscibili, come in seguito si andrà ad esporre.
Il primo caso di azione revocatoria è quello indicato
nell' art. 64 l.f. che prevede l' inefficacia degli atti a
titolo gratuito compiuti nei due anni precedenti alla dichiarazione
di fallimento ; in questo caso la dichiarazione di inefficacia
è ex se, senza la necessità di compimento di
alcun onere particolare della curatela, che dovrà solamente
dimostrare che l' atto di liberalità sia stato compiuto
nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento.
La ragione di tanta facilità di prova è chiara
; non avendo l' atto di liberalità inciso sul patrimonio
del donatario, la sua inefficacia nessuna conseguenza patrimoniale
potrà comportare ( l' inefficacia dell' atto pertanto
opererà senza che il beneficiario possa opporre la
mancata conoscenza dello stato di insolvenza, che al riguardo
si presenta come condizione neutra).
Il concetto di atto a titolo gratuito è stato inteso
dalla giurisprudenza in una concezione piuttosto ampia, tale
dal far ritenere che qualsiasi atto senza corrispettivo rientri
nella disposizione in esame ; pertanto atto a titolo gratuito
è considerato il pagamento di un debito scaduto, la
costituzione di un fondo patrimoniale ex art. 167 l.f.. In
particolare, per quanto riguarda il debito altrui, la non
onerosità va commisurata con riguardo al fallito pagante
ed il terzo soddisfatto, ma non tra il fallito e colui a favore
del quale egli effettua l' adempimento ; pertanto anche in
questo caso la disciplina applicabile è quella di cui
all' art. 64 c.c.. Il problema si poi in particolare per il
pegno rotativo, nel quale cioè alla scadenza di un
termine il debitore può sostituire il bene dato in
pegno o rinnovare la garanzia ; in questo caso vi è
chi dubita che si tratti di atti a titolo gratuito in quanto
la rinnovazione del pegno viene effettuata a garanzia di una
obbligazione originaria ; qualora però il debito originario
sia stato adempiuto e nonostante ciò venga effettuata
una sostituzione dell' oggetto del pegno, si è in presenza
di un atto a titolo gratuito, indipendentemente dal fatto
che detta previsione sia stata contrattualmente prevista.
Restano esclusi dalla disciplina ora esaminata gli atti compiuti
in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità,
purchè la liberalità sia proporzionata al patrimonio
del donante ; in questo caso occorre una indagine in concreto
per accertare se la liberalità sia dovuta in adempimento
di un dovere morale, cioè di un dovere ritenuto tale
dalla morale comune, oppure per una discrezionalità
del donante, come nel caso della donazione remuneratoria,
ove in tal caso l' atto sarà revocabile ; incombe in
questo caso, ad opinione di chi scrive, sul convenuto l' onere
probatoria relativo all' adempimento del dovere morale o dello
scopo di pubblica utilità.
Simile al sospetto adombrato in caso di liberalità
antecedente alla dichiarazione di fallimento è quello
dell' imprenditore che paga in un lasso di tempo compreso
in due anni prima del fallimento i debiti scaduti il giorno
del fallimento o successivamente, e ciò indipendentemente
dall' esercizio di tale facoltà accordata al debitore
; anche in questo caso la legge vede con sospetto un imprenditore
commerciale, la cui attività ha per scopo primario
il lucro, il quale invece di "procastinare" il giorno
dell' adempimento, lo anticipi ; anche qui è indifferente
la conoscenza dello stato di insolvenza o il pregiudizio arrecato
agli altri creditori, ma quel che conta è il fatto
oggettivo del pagamento entra l' arco temporale stabilito
dal legislatore.
La disciplina degli atti a titolo oneroso è stabilità
dall' art. 67 l.f..
Detta norma, come si è in precedenza accennato, stabilisce
precisi limiti temporali al di là del quale essa non
opera ed il curatore deve agire in base all' art. 2901 c.c.,
e presunzioni relative.
La prima presunzione è quella di cui al comma 1 in
base alla quale, per gli atti elencati nello stesso, è
l' altra parte che deve dimostrare l' inesistenza dello stato
di insolvenza del debitore : detti atti sono :a) quelli a
titolo oneroso compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione
di fallimento in cui vi sia sproporzione tra prestazioni ;b)
gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili
non effettuati con danaro o con mezzi normali di pagamento,
compiuti entro i due ani precedenti la dichiarazione di fallimento
; c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituite
entro l' anno dalla dichiarazione di fallimento per debiti
preesistenti non scaduti ; d) i pegni le anticresi e le ipoteche
giudiziali o volontarie costituite entro l' anno dalla dichiarazione
di fallimento per debiti scaduti. Come si vede la caratteristica
principale degli atti in questione è la presunzione
di conoscenza dello stato di insolvenza ; in sostanza, trattandosi
di atti anormali di gestione in quanto o vi è sproporzione
tra le prestazioni o non vi è un diretto utile economico
(elemento inconciliabile con una corretta gestione imprenditoriale),
grava su chi è convenuto in revocatoria provare di
non essere a conoscenza dello stato di insolvenza. Naturalmente
per tutta questa categoria di atti l' anormalità o
sproporzione tra le prestazioni deve sussistere al momento
in cui l' atto fu compiuto. Se per esempio un bene acquistato
in un periodo sospetto perisce per caso fortuito non si può
parlare di pregiudizio in quanto non vi è un nesso
causale con il fatto ; così, per ipotesi, se il bene
alienato improvvisamente ed imprevedibilmente aumenta di valore,
tanto da rientrare nel nr 1) del comma 1, non si può
parlare di sproporzione tra le prestazioni in quanto detta
sproporzione all' epoca del compimento dell' atto era tutt'
altro che scontata.
Per quanto riguarda il nr 1) dell' art. 67 l.f., si fa espresso
riferimento ad atti a titolo oneroso a carattere sinallagmatico.
Il caso più frequente è quello della vendita
da parte del fallito, di beni di sua proprietà ( o
della società) ad un prezzo notevolmente inferiore
a quello di mercato. In questo caso, in genere, il convenuto
in revocatoria potrà eccepire la simulazione relativa
del contratto in quanto il prezzo dichiarato nell' atto di
vendita è inferiore a quello di mercato poiché
in questo modo si potevano trarre benefici fiscali (ed es.
pagamento di tassa di registro in misura minore a quella dovuta)
opponendo alla curatela una contro dichiarazione dalla quale
si evince il prezzo effettivo. Ebbene, proprio in questa ipotesi
riveste di particolare importanza la qualifica di curatore
quale terzo, poiché se la contro scrittura non ha data
certa anteriore al fallimento essa non gli sarà opponibile
ed il giudice potrà dichiarare senza effetto l' alienazione
; analogamente varranno i limiti che il codice civile pone
alla prova per testi nel caso si voglia provare l' esistenza
di patti aggiunti o contrari all' atto scritto redatti anteriormente
o contemporaneamente allo stesso, ex art. 2722 c.c.; per quanto
riguarda la differenza di prezzo tale da potersi affermare
la revocabilità, la giurisprudenza è concorde
nel ritenere che non deve trattarsi della differenza prevista
dal legislatore per l' azione di rescissione, ma basta uno
scarto tra il 25% - 30% tra il prezzo dichiarato e quello
reale (accertabile con CTU) per rientrare nell' ipotesi contemplata.
Accanto al contratto di vendita in cui vi è sproporzione
tra le prestazioni, sono ritenuti revocabili il contratto
di appalto, quello di transazione, quello di locazione ; in
questo caso quanto il fallito sia locatore oltre alla revocazione
del contratto al curatore spetterà un' indennità
di occupazione fino all' effettivo rilascio ; nel caso in
cui fallito è il conduttore è stata ritenuto
revocabile il contratto se il canone di locazione era eccezionalmente
oneroso; il contratto di cessione di quote sociali qualora
il valore di vendita sia inferiore a quello reale, il contratto
di appalto e quello di permuta.
L' altra ipotesi di anormale gestione imprenditoriale comprende
"gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili
non effettuati con denaro o altri mezzi normali di pagamento"
I questo caso l' anormalità sta nei mezzi con cui viene
pagato il creditore : in questa fattispecie rientrano la dazione
di merci, i mandati a vendere con diritto di soddisfarsi sul
ricavato, la compensazione convenzionale di un credito non
pecuniario con un debito pecuniario scaduto ed esigibile,
la prestazione di un servizio, l' accollo privativo disciplinato
dall' art. 1273 comma 2 cc, la trattenuta, da parte del committente,
di provvigioni dovute al commissionario al fine di recuperare
il proprio credito verso quest' ultimo ; di contrastante indirizzo
è la giurisprudenza in caso di pagamento con assegni
post datati.
Rientrano inoltre nella azione revocatorie i pegni le anticresi
e le ipoteche volontarie costituite nei due anni anteriori
alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non
scaduti ; è evidente come in questo caso è anormale
che per un debito preesistente non scaduto si costituiscano
garanzie, cioè che le garanzie non siano state costituite
contestualmente al nascere del debito ; in questa particolare
ipotesi, oltre a ledersi la par condicio creditorum, al cui
fine è protesa tutta la legislazione fallimentare,
si ha in concreto un soddisfacimento di un singolo creditore
il quale, per un motivo per l' altro, è stato in grado
in maniera anormale di costituirsi una garanzia. Per quanto
riguarda la sorte del suo credito una volta posta nel nulla
la garanzia creata a suo favore, la legge fallimentare prevede
il rimedio generale di ammissione al passivo per colui che
ha restituito quanto aveva riscosso ; pertanto se l' esame
dello stato passivo è ancora aperto, egli potrà
insinuarsi ai sensi degli art. 93 e ss. l.f., in caso contrario
non gli resta che l' azione ex art. 101 l.f.. Beninteso la
sua ammissione sarà ristretta al pregiudizio che ha
subito, da valutarsi in natura se, per esempio, viene revocato
un pagamento, o per equivalente in caso di revoca di alienazioni
o di pagamento con mezzi anormali. E' stato ritenuto revocabile,
ad esempio, la fattispecie realizzatasi "qualora un mutuo
ipotecario venga stipulato a copertura di un' anticipazione
in precedenza concessa dalla banca mutuante, senza che il
mutuatario acquisisca la disponibilità della somma
mutuata, l' ipoteca integra garanzia costituita per un debito
preesistente e, quindi, in caso di fallimento dell' obbligato,
resta soggetta a revocatoria ai sensi dell' art. 67 comma
1 l.f."( Cass. sez. I 18.11.1992 nr 12342) ; ed ancora
"quando l' apertura di credito sia destinata a ridurre
passività pregresse, invece che ad assicurare una ulteriore
disponibilità per il cliente, la garanzia eventualmente
costituita in quella occasione deve intendersi riferita al
debito preesistente e la sua revocabilità è
conseguenza regolata dal primo anziché dal secondo
comma dell' art. 67 l.f." (Cass sez. I 21.12.1998 nr
12740)
Infine vi sono le garanzie non contestuali per debiti scaduti.
In questo caso da un lato il legislatore, proprio perché
il debito è scaduto, limita ad un anno il periodo sospetto,
ed amplia la casistica alle ipoteche giudiziali, in quanto
in questa ipotesi il debitore avrebbe potuto evitare l' iscrizione
con il richiede il proprio fallimento.
Passiamo ora all' altra grande categoria di atti revocabili
diversi da quelli or ora esaminati, ovvero i pagamenti.
Afferma la legge fallimentare al comma 2 dell' art. 67 che
"sono altresì revocati, se il curatore prova che
l' altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti contestualmente creati, se compiuti entro l' anno dalla
dichiarazione di fallimento".
In questo caso il limite temporale per aversi azione revocatoria
è più limitato di quelli stabiliti generalmente
ai numeri precedenti in quanto i pagamenti e gli atti elencati
al comma due costituiscono atti normali di gestione a meno
che il curatore non fornisca la prova che l' altra parte provi
la conoscenza dello stato di insolvenza. Al riguardo numerosissime
sono le decisioni giurisprudenziali sul punto, attesa la varia
gamma di atti ricompresi nel dettato della norma ed i vari
tipi di pagamento che possono aversi in natura.
Il primo problema riguarda la revocabilità o meno di
crediti assistiti da privilegio. In questo caso vi è
una parte della dottrina che propende per l' ipotesi negativa
in quanto essendo il credito privilegiato esso troverebbe
comunque soddisfazione nel caso di esistenza di attività
; si è obiettato che in questo caso vi sarebbe disparità
tra creditori privilegiati pagati entro l' anno dalla dichiarazione
di fallimento e creditori privilegiati insinuatisi al passivo
; la giurisprudenza è comunque ormai propensa per la
revocabilità, atteso il principio assolutistico ed
inderogabile della par condicio creditorum. Un caso interessante
è quello del pagamento coatto, effettuato tramite esecuzione
presso terzi, da parte di dipendenti della società
fallita. Premesso che in questo caso l' art. 2 della L. 297/1982
stabilisce a carico di un fondo istituito presso l' INPS il
pagamento del TFR in caso di fallimento del datore di lavoro,
non vi è alcun ostacolo concettuale a ritenere revocabile
il pagamento ottenuto dal prestatore di lavoro a titolo di
TFR ; questo sia per la diversità di procedura, in
quanto vi potrebbe essere il caso di lavoratori che hanno
ottenuto dal giudice l' assegnazione di somme e lavoratori
che invece si sono insinuati al passivo attendendo la approvazione
dello stato passivo, e sia perché comunque le somme
ottenute dai lavoratori esecutanti fanno parte della massa
passiva e deve concorrere tutta alla ripartizione dell' attivo.
Per cui nella pratica l' azione revocatoria colpirà
non il provvedimento giurisdizionale di aggiudicazione delle
somme, ma il successivo pagamento effettuato in adempimento
di quanto precede. Circa la prova dello stato di insolvenza,
l' aver da parte dei lavoratori iniziato una procedura esecutiva
individuale è già di per sé sintomo di
decozione dell' imprenditore ; se a ciò si aggiunge,
ad esempio, la presentazione da parte dei lavoratori di altri
procedimenti monitori, provati documentalmente dalla curatela
agente, non può non ritenersi soddisfatto l' onere
previsto dalla norma a carico della procedura. Costituiscono
comunque altri indici di prova dello stato di insolvenza la
pubblicazione del nominativo del fallito sul bollettino ufficiale
dei protesti, la presentazione da parte del creditore convenuto
in revocatoria del ricorso che ha portato al fallimento dell'
imprenditore o di ricorso aventi lo stesso fine ma reietti
in data precedente dal tribunale, la presentazione di procedure
esecutive individuali. E' ovvio che la casistica appena elencata
lungi dall' essere esaustiva, costituisce solamente una esemplificazione
delle varie ipotesi in cui si possa provare lo stato di insolvenza.
Dubbi sorgono per le dichiarazioni rese dallo stesso creditore
in cui si fa riferimento a dizioni quali stato di insolvenza,
come per esempio nelle missive di messa in mora nelle quali
si minaccia, in caso di inadempimento, la presentazione di
ricorso di fallimento ; trattasi infatti di atti unilaterali
che, a mio modo di vedere, non hanno alcun valore confessorio
in quanto diretti verso terze persone ; ma nulla esclude che
un attento esame del complesso contesto intercorso tra il
creditore ed io debitore successivamente dichiarato fallito
possa far propendere per l' ipotesi affermativa ; è
comunque una questione da accertare con estrema attenzione
e caso per caso, non potendo in materia sussistere certezze.
Revocatoria dei pagamenti effettuati al difensore. Nulla quaestio
per i pagamenti effettuati al difensore nella fase di opposizione
alla sentenza dichiarativa di fallimento, i quanto si rientra
nell' ipotesi dell' art. 44 l.l.. Il problema si prone per
l' assistenza prestata nel caso di presentazione di concordato
preventivo poi rigettato dal tribunale. Sul punto la norma
è chiara, in quanto l'imprenditore che si trova in
stato di insolvenza può chiedere ai creditori un concordato
preventivo. Sebbene proprio il debitore possa di persona presentare
ricorso per concordato preventivo, nulla esclude che egli
si faccia assistere da un difensore, che, necessariamente,
verrà fatto partecipe dello stato di insolvenza. Pertanto
non è il caso di soffermarsi sulla conoscenza dello
stato di insolvenza, ma sulla opportunità di un azione
revocatoria in questo caso. Se si ammettesse la possibilità
di agire in revocatoria, o si priverebbe il fallendo di assistenza
o si obbligherebbe il difensore a prestare la sua opera per
il momento gratuitamente, salvo poi ad ammettere il credito
in sede di verifica. La soluzione più equa e più
rispondente al dettato costituzionale è quella di una
interpretazione evolutiva dell' art. 67 l.f. adattandola all'
art. 24 della Costituzione che garantisce il diritto di difesa
in ogni stato e grado del procedimento, sebbene, per gli scarsi
precedenti in materia, la questione è ancora aperta.
Altro punto rilevante è la revocabilità dei
pagamenti che l' imprenditore è obbligato ad effettuare,
non previsti da una normativa speciale, come nel caso del
pagamento agli enti gestori delle somme dovute per forme obbligatorie
di assistenza e previdenza (art. 1 comma 223 L 662/1996 )
ai crediti per le medie e piccole industrie e imprese artigiane
ex art. 20 L. 30.7.1959 nr 623).
Infine in via di fatto la giurisprudenza ha escluso la revocabilità
dei pagamenti effettuati ad imprese che esercitano attività
in regime di monopolio legale, dato che "le imprese che
operano in regime di monopolio legale si sottraggono all'
applicazione della revocatoria fallimentare per il pagamento
di debiti liquidi ed esigibili, in quanto la normativa che
impone all' impresa monopolistica di contrattare con chiunque
e di trattare allo stesso modo tutti gli utenti, attiene non
solo al momento genetico del contratto ma anche a quello che
riguarda la fase di esecuzione del negozio, posto che deve
essere esclusa per il monopolista legale la facoltà
di avvalersi, nel caso di insolvenza dell' utente, del rimedio
della sospensione dell' erogazione del servizio" (Cass
S.S.U.U. 11.11.1998 nr 11350)
Altra categoria di pagamenti per i quali vi è grosso
dibattito in dottrina ed in giurisprudenza riguarda la revocabilità
dei versamenti effettuati attraverso Istituti di Credito,
con eccezioni di quelli di cui al comma 4 dello stesso articolo.
Premessa di carattere concettuale è l' inquadramento
del più diffuso contratto bancario, ovvero il contratto
di apertura di credito in conto corrente. In questo particolare
contratto l' apertura di deposito e le altre operazioni bancarie
sono regolate in conto corrente, e pertanto le parti annotano
in apposito conto le reciproche rimesse, da considerarsi inesigibili
fino alla chiusura del conto. Orbene, data la particolare
natura del contratto di conto corrente, è innanzitutto
da stabilire se le operazioni effettuate in conto corrente
siano esecuzione di un medesimo contratto o se siano atti
dotati di particolare autonomia ; nel primo caso, infatti,
la banca potrà eccepire di aver adempiuto al contratto
di conto corrente per andare esente da responsabilità,
a meno che non si voglia impugnare l' intero contratto di
conto corrente bancario, mentre nel secondo caso, considerando
ogni prestazione come dotata di propria autonomia, ben potranno
singole rimesse essere assoggettate ad azione revocatoria.
Sul punto è stato affermato, in via di fatto, dalla
giurisprudenza il principio della revocabilità delle
rimesse effettuate dal cliente oltre il limite di "scoperto"
convenzionalmente pattuito con l' Istituto di credito ; ed
infatti nel caso di versamenti entro il limite del fido si
è affermati che i medesimi non hanno natura solutoria,
ma lo scopo di ripristinare la provvista ; nel caso in cui
invece il cliente abbia agito oltre i limiti dello scoperto,
in quanto permesso dalla banca, il successivo versamento ha
natura solutoria di un debito verso l' istituto ed è
pertanto revocabile ai sensi dell' art. 67 l.f.(I versamenti
sul conto corrente del correntista poi fallito hanno natura
di pagamenti, e sono quindi soggetti alla revocatoria fallimentare
ai sensi dell' art. 67 secondo comma l.f. (se eseguiti nel
periodo sospetto e ricorrente la scientia decoctionis), soltanto
nell' ipotesi di conto "scoperto", quando cioè
la banca abbia anticipato somme oltre il limite del fido,
mentre nell' ipotesi di conto semplicemente "passivo",
assistito da apertura di credito, non è configurabile,
durante lo svolgimento del rapporto e fino a quando i prelievi
sono contenuti nei limiti del fido, un credito esigibile della
banca verso il correntista, in quanto i versamenti - eseguiti
direttamente dal cliente e mediante beneficio di somme provenienti
da terzi - consistendo in semplici operazioni di accreditamento
dirette a ripristinare la provvista, non hanno funzione solutoria.
In caso di conto assistito da apertura di credito sono tuttavia
revocabili le rimesse che appaiono, con accertamento ex post,
avere concretamente e definitivamente concorso a ridurre il
debito verso la banca, determinando (come quando il conto
sia chiuso anticipatamente) un rientro della banca stessa
mediante il prelievo dalla provvista di una somma pari al
fido utilizzato dal correntista Cass sez I 29.7.1992 nr 9064).
Corollario di siffatto principio è stato affermato
di recente dalla giurisprudenza nel caso di pagamento effettuato
da un terzo a mezzo accredito di somme sul conto corrente
del fallito ; infatti è stato stabilito dalla Corte
di Cassazione (Cass. sez. I 16.11.1998 nr 11520) che il pagamento
del terzo avente natura ripristinatoria non è soggetto
a revocatoria, ma quello a carattere solutorio per scoperto
del fallito oltre i limiti del fido va considerato revocabile
sussistendo il presupposto soggettivo ; è stato inoltre
precisato che è questione di fatto, da accertare in
concreto caso per caso, se il terzo abbia pagato un debito
del fallito o un debito che il fallito aveva nei suoi confronti.
E' stato inoltre affermato il principio in base al quale la
banca non può operare la compensazione in relazione
a rapporti di debito credito nascenti da unico contratto di
conto corrente. L' art. 1853 c.c stabilisce che, salvo patto
contrario, se tra la banca ed il correntista vi sono più
rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano
reciprocamente. Detto principio è l' estensione naturale
dettata in tema di compensazione legale dall' art. 1243 in
base al quale la compensazione legale opera tra di debiti
di danaro o altre cose fungibili ; se invece il conto è
unico la banca non può unilateralmente effettuare la
compensazione tra il dare e l' avere, in quanto in questo
modo viene meno il rapporto sinallagmatico tra le due prestazione
poiché si attribuisce ad un solo contraente la possibilità
di decidere, unilateralmente, se esista o meno un proprio
debito
Da ultimo va affrontato il problema relativo all' utilità
dell' esercizio della azione revocatoria nel caso in cui lo
stato passivo sia negativo, ovvero non vi siano passività
di terzi accertate. In tal caso infatti il fallimento ben
potrebbe chiudersi ai sensi dell' art. 118 nr 1) E 2) L.F..
Il primo caso riguarda la mancata proposizione di domande
di ammissione al passivo, il secondo caso riguarda l' estinzione
dei crediti ed il pagamento del compenso al curatore. Sebbene
apparentemente diverse le fattispecie possono inquadrarsi
unitariamente in relazione al disposti dell' art. 111 nr 1)
l.f. che stabilisce la priorità per il pagamento delle
spese dell' amministrazione fallimentare, comprese quelle
anticipate dall' erario. Pertanto, in mancanza di passività,
vi saranno comunque delle spese anticipate dall' erario (eventuale
trascrizione della sentenza presso il PRA o Conservatorie
Immobiliari, pagamento dei cancellieri per le operazioni di
inventario, spese di registrazione) ed il compenso al curatore
(da calcolare secondo l' attivo ed il passivo ipotizzabile)
che vanno pagati al fine di chiudere la procedura ex art.
118 nnrr 1) e 2); di conseguenza, anche nel caso di estinzione
dei crediti, qualora non fossero adempiuti i pagamenti citati
e l' attivo fosse insufficiente, ma vi fosse la possibilità
di far dichiarare giudizialmente inefficace degli atti, è
opinione di chi scrive che ben potrebbe il curatore richiedere
la autorizzazione al g.d. per agire in giudizio.
SEZ. 1 SENT. 04718 DEL 28/04/1995 RV. 492043
PRES. Corda M REL. Marziale G COD.PAR.171
PM. Martone A (Parz. Diff.)
RIC. Banca Agricola Mantovana
RES. Fall.to S.a.s. Confezioni Edda
Con il "castelletto di sconto", a differenza di
quanto avviene nell'apertura di credito, la banca non attribuisce
al cliente la facoltà di disporre immediatamente di
una somma di denaro, ma si impegna ad accettare per lo sconto,
entro un ammontare predeterminato, i titoli che l' affidatario
presenterà, sicche', nell'ipotesi indicata, il "fido"
non rappresenta l'ammontare delle somme di cui il cliente
può disporre (in quanto queste saranno determinate
dall' entità degli accreditamenti effettuati a seguito
delle singole operazioni di sconto), bensì il limite
entro il quale la banca e' tenuta ad accettare i titoli presentati
dal cliente. Pertanto, l'esistenza di un "fido"
per lo sconto di cambiali non può far ritenere "coperto"
un conto corrente bancario, ne' può valere ad escludere
il carattere solutorio delle rimesse effettuate dal cliente,
poi fallito, su tale conto.
SEZ.
1 SENT. 01083 DEL 05/02/1997 RV. 502217
PRES. Vessia A REL. Losavio G COD.PAR.171
PM. Leo A (Conf.)
RIC. Banco di Sicilia
RES. Fall. Officina Meccanica
Con il "castelletto di sconto" o con il cd. "fido
per smobilizzo di crediti", a differenza di quanto avviene
nell'apertura di credito, la banca non attribuisce al cliente
la facoltà di disporre immediatamente di una somma
di denaro, ma si impegna ad accettare per lo sconto, entro
un ammontare predeterminato, i titoli che l' affidatario presenterà,
sicche', nell'ipotesi indicata, il "fido" non rappresenta
l'ammontare delle somme di cui il cliente puo' disporre (in
quanto queste saranno determinate dall'entita' degli accreditamenti
effettuati a seguito delle singole operazioni di sconto),
bensi' il limite entro il quale la banca e' tenuta ad accettare
i titoli presentati dal cliente. Pertanto, l'esistenza di
un "fido" per lo sconto di cambiali non puo' far
ritenere "coperto" un conto corrente bancario, ne'
puo' valere ad escludere il carattere solutorio delle rimesse
effettuate dal cliente, poi fallito, su tale conto.
SEZ.
1 SENT. 00656 DEL 21/01/2000 RV. 533039
PRES. Sgroi R REL. Cappuccio G COD.PAR.171
PM. Gambardella V (Conf.)
RIC. Cassa Risp. Padova e Rovigo S.p.a.
RES. Falli. Costruzioni Elettriche Guerra Luciano s.n.c.
Premesso che il castelletto non costituisce una apertura di
credito, in quanto comporta soltanto l'impegno della banca
ad accettare operazioni di sconto sino ad un certo importo,
lo sconto bancario si concreta in un mandato alla banca a
riscuotere il titolo ed in un accredito del relativo importo
in conto corrente, subordinato alla condizione sospensiva
del salvo incasso, con la doppia conseguenza che l'importo
dell'accredito in conto corrente non e' disponibile se non
dopo che il titolo e' stato pagato, e che, in caso di mancato
pagamento, l'addebito in conto corrente costituisce una mera
operazione contabile di storno, non inquadrabile nella ipotesi
di compensazione, che presuppone la sussistenza di piu' rapporti
con effettivi debiti e crediti reciproci, e, che, pertanto,
non puo' essere invocata ai fini della esclusione della revocatoria
fallimentare nei confronti delle rimesse di cui si tratta.
SEZ.
1 SENT. 04598 DEL 22/05/1997 RV. 504635
PRES. Senofonte P REL. Rordorf R COD.PAR.171
PM. Nardi D (Diff.)
RIC. Fond. Cassa Risp. Verona
RES. Fall. Boxitalia
In virtu' del principio di buona fede, operante non solo in
sede d'interpretazione ed esecuzione del contratto (artt.
1366 e 1375 c.c.), ma anche quale fonte d'integrazione della
stessa regolamentazione contrattuale (art. 1374 c.c.), al
curatore che richiede la documentazione concernente i rapporti
di conto corrente intestati al fallito, sul presupposto di
non avere avuto la possibilità di procurarseli direttamente
da quest'ultimo e per la necessita' che la sua carica gli
impone di ricostruire le vicende del patrimonio del fallito,
la banca ha l'obbligo di trasmettere la richiesta documentazione,
sebbene a spese del richiedente, senza poter replicare di
averla già in precedenza trasmessa al fallito stesso.
Nel formulare la richiesta, il curatore non ha l'obbligo di
indicare in dettaglio gli estremi dei documenti bancari dei
quali vuole ottenere la consegna, tuttavia deve fornire quegli
elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione
degli stessi e, nel caso in cui la banca neghi l'esistenza
dei documenti in questione, e' pur sempre il curatore a dover
dimostrare, anche a mezzo di presunzioni, che, viceversa quei
documenti esistono e, percio', la banca e' tenuta a consegnarli.
SEZ.
1 SENT. 11733 DEL 19/10/1999 RV. 530695
PRES. Corda M REL. Papa E COD.PAR.732
PM. Nardi V (Conf.)
RIC. Banca di Roma SpA
RES. Fall. Pro.Ma. Srl
Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario
la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni
dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art.
119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, si configura come un diritto
sostanziale la cui tutela e' riconosciuta come situazione
giuridica "finale" e non strumentale, onde per il
suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione
che il cliente intende fare della documentazione, una volta
ottenuta la e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione
debba essere necessariamente funzionale all'esercizio di diritti
inerenti il rapporto contrattuale corrente con l'istituto
di credito (ben potendo, ad esempio, essere finalizzata a
far emergere un illecito, anche non civilistico, di un terzo
soggetto o di un dipendente della banca). Nel caso di fallimento
del cliente il suddetto diritto si trasmette al curatore,
posto che questi subentra - ai sensi dell'art. 31 della legge
fallimentare - nell'amministrazione del patrimonio del fallito
sotto la direzione del giudice delegato e considerato che
detto diritto e' una componente di quel patrimonio. In ragione
della natura "finale" del diritto in questione,
l'istituto bancario, richiesto dal curatore della consegna
della copia della documentazione, non puo' rifiutarla adducendo
l'intenzione del curatore di utilizzare la documentazione
in funzione dell'esercizio di eventuali azioni revocatorie
e nemmeno puo' pretendere che, a seguito di esercizio da parte
del curatore in sede giudiziale del diritto alla consegna,
la sentenza che riconosca tale diritto escluda quella utilizzazione
(la Suprema Corte ha anche osservato che lo scioglimento automatico,
ex art. 78 della legge fallimentare, del contratto di conto
corrente - cui nella specie si correlava il diritto alla consegna
della copia della documentazione - non toglie che il diritto
ex art. 119 citato, configurandosi anche dopo la cessazione
del rapporto, si trasmetta al curatore).
SEZ.
1 SENT. 02538 DEL 28/03/1990 RV. 466228
PRES. CATURANI G REL. SAGGIO A COD.PAR.171
PM. DONNARUMMA U (DIFF)
RIC. FALLSOCMAGLIVE
RES. BANCA POP VE
In tema di revocatoria fallimentare dei versamenti sul conto
corrente bancario del fallito, il principio, secondo il quale,
nel caso di apertura di credito, con prelievi contenuti nei
limiti del "fido", i versamenti stessi, eseguiti
direttamente ovvero mediante bonifichi di somme provenienti
da terzi, non hanno funzione solutoria, e quindi si sottraggono
a revocatoria, trova deroga ove detti bonifichi risultino
in concreto mezzi anomali di pagamento di pregresse esposizioni
debitorie verso la banca, come quando il cliente, contestualmente
all'apertura di credito, abbia ceduto alla banca tutti i propri
crediti, a copertura delle passivita' di conto.
SEZ.
1 SENT. 02744 DEL 22/03/1994 RV. 485854
PRES. Favara F REL. Bibolini GC COD.PAR.171
PM. Morozzo Della Rocca F (Conf)
RIC. Fallimento Cassetti
RES. Banca Agricola Mantovana
Le rimesse effettuate dall'imprenditore, poi fallito (o da
un terzo), sul proprio conto corrente bancario nel periodo
"sospetto" di cui all'art. 67, comma secondo, legge
fall. sono suscettibili di azione revocatoria fallimentare
soltanto se, all'atto della rimessa, il conto risulti "scoperto"
(intendendosi tale sia il conto non assistito da apertura
di credito che presenti un saldo passivo, sia il conto scoperto
a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato
al correntista). All'indicato fine, dovendosi verificare se
la rimessa abbia funzione "solutoria" (lesiva della
"par condicio creditorum") ovvero semplicemente
ripristinatoria della provvista, la "copertura"
o meno del conto va accertata con riferimento al "saldo
disponibile", da determinarsi in ragione delle epoche
di effettiva esecuzione, da parte della banca, degli incassi
e delle erogazioni, non gia' con riferimento esclusivo al
"saldo contabile" - che riflette la registrazione
delle operazioni in ordine puramente cronologico -, ne' al
"saldo per valuta" - che e' effetto del posizionamento
delle partite unicamente in base alla data di maturazione
degli interessi -. Sul piano probatorio, tuttavia, non risultando
dall'estratto conto l'effettivo saldo disponibile, elementi
presuntivi di prova possono desumersi sia dalla data di registrazione
in conto delle operazioni - limitatamente a quelle "in
avere" del correntista, costituite da versamenti e bonifici
in contanti, nonche' ai prelevamenti in contanti o a mezzo
assegni -, sia dai dati ordinati "per valuta" -
limitatamente ai versamenti in conto di titoli di credito,
dovendosi presumere che l'incasso sia avvenuto, quanto meno,
alla data della valuta, salva la possibilita', per la banca,
di provare che sia avvenuto anteriormente.
SEZ.
1 SENT. 01727 DEL 17/02/1995 RV. 490490
PRES. Sensale A REL. Graziadei G COD.PAR.171
PM. Aloisi M (Conf.)
RIC. S.p.A. Credito italiano
RES. Amministrazione straordinaria S.p.A. Metallotecnica Sarda
La natura solutoria del versamento su conto corrente bancario
assistito da apertura di credito, al fine dell'assoggettamento
a revocatoria ai sensi dell'art. 67 secondo comma della legge
fallimentare, va riconosciuta non solo quando il versamento
stesso vada a ripianare uno scoperto verificatosi oltre il
limite della disponibilita' concessa al cliente, ma anche
quando, pur inserendosi in una situazione di mera passivita'
del conto, per anteriore utilizzo della provvista nel rispetto
di quel limite, non acquisti in concreto funzione ripristinatoria
di tale provvista, perche' sia incamerato, con la chiusura
del conto, a tacitazione della conseguenziale obbligazione
restitutoria (divenuta liquida ed esigibile), senza che al
riguardo rilevi la circostanza che detta chiusura sia frutto
di iniziativa del cliente anziche' della banca.
SEZ.
1 SENT. 10848 DEL 05/12/1996 RV. 501049
PRES. Borruso R REL. Bibolini GC COD.PAR.171
PM. Lo Cascio G (Conf.)
RIC. Comm. Giud. Siderurgica Meridionale
RES. CARIPLO S.p.A.
Nell'ipotesi in cui sussista e sia in corso un'apertura di
credito regolata in conto corrente ed il relativo limite di
fido non sia stato superato, non puo' individuarsi alcun obbligo
restitutorio attuale da parte del correntista, il quale, secondo
le facolta' consentite dal singolo contratto, ha la possibilita'
di reintegrare la provvista per poterne ulteriormente disporre.
Invece, in tutti gli altri casi in cui o venga superato il
limite di fido (e, quindi, si esca dall'operativita' di quel
contratto), ovvero non sussista un rapporto derivante da apertura
di credito, per cui l'anticipazione eseguita dalla banca implichi
un obbligo di restituzione, il versamento in conto ha funzione
solutoria ed assume la veste di "pagamento" rilevante
ai fini della revocatoria fallimentare. Una volta proposta
tale ultima azione, l'attore puo' limitarsi a sostenere che
tali versamenti, intesi come fatti solutori, avvennero per
il rimborso di somme anticipate dalla banca in conto corrente,
mentre costituisce onere della banca provare la sussistenza
dell'apertura di credito ed il suo limite.
SEZ.
1 SENT. 11520 DEL 16/11/1998 RV. 520713
PRES. Cantillo M REL. Morelli MR COD.PAR.171
PM. Sepe EA (Conf.)
RIC. BANCA NAZ. AGRICOLTURA SPA
RES. FALL. INNORD SRL
In tema di azione revocatoria fallimentare, mentre il pagamento
di un debito del fallito da parte del terzo e' passibile di
revoca ex art. 67 legge fall. solo se compiuto con denaro
dell'imprenditore poi fallito (ovvero a seguito di esercizio
della rivalsa da parte del terzo prima della dichiarazione
di fallimento), nella (diversa) ipotesi in cui il terzo abbia
compiuto un versamento sul c/c dell'imprenditore quest'ultimo
acquista la titolarita' della rimessa, con conseguente assoggettabilita'
dei versamenti alla regola per la quale la revocabilita' e'
condizionata alla funzione solutoria e non meramente ripristinatoria
della provvista nei confronti della banca.
|