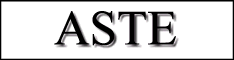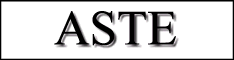|
"La
Revocatoria Fallimentare
(retroattività e azioni di reintegrazione) in Spagna
(1)"
Isabel Candelario Macias,
Prof.ssa di Diritto Commerciale, Università Carlos
III di Madrid, Spagna
Sommario: 1.- PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTZIONE: A) LA RETROATTIVITA'.
B) ATTI INEFFICENTI IN RAGIONE ESCLUSIVA DEL PERIODO NEL QUALE
FURONO REALIZZATI. C) ATTI ANNULABILI PREVIA PROVA DELLA FRODE.
2.- CONCLUSIONI. 3- BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO.
1.-
PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO:
Una delle questioni più difficili da affrontare nella
pratica del procedimento del fallimento spagnolo è
la delimitazione della massa destinata a soddisfare i creditori.
A nessuno sfugge che il fallimento non si produce in modo
improvviso. Di norma viene preceduto da un periodo più
o meno lungo durante il quale l'impresario tratta, per prima
cosa, di rimediare alla sua situazione e, dopo, di diminuire
gli effetti dell'inevitabile fallimento con operazioni sui
suoi beni pregiudizievoli per tutti i creditori, o in beneficio
di alcuni e pregiudizievoli per altri.
Contro questo pericolo ha reagito la Legge in ogni momento
storico. Il Diritto Romano conobbe la actio pauliana ordinaria
allo scopo di impugnare gli atti del debitore fatti in frode
ai creditori; azione conosciuta da tutti gli ordinamenti legali
e concretamente dal nostro codice civile (art. 1111 e 1291.3).
In caso di fallimento tuttavia non risultava sufficiente la
protezione che offriva questa azione e fu necessario fissare
un sistema di nullità per determinati atti del fallito
anteriori alla dichiarazione di fallimento, riconoscendo al
giudice allo stesso tempo la facoltà di determinare,
facendo riferimento alle circostanze del caso, il periodo
immediatamente anteriore al fallimento durante in quale avrebbero
dovuto realizzarsi gli atti annullabili, oppure fissando la
Legge questo periodo, oppure ancora stabilendo un sistema
misto (2), come è in realtà il nostro (3).
Secondo quanto detto, possiamo fare differenza tra la actio
pauliana classica ereditata dal Diritto civile e la actio
revocatoria fallimentare. Infatti, l'azione pauliana pretende
proteggere i creditori di fronte al debitore che non rispetta
la garanzia disposta dall'articolo 1911 del Codice civile.
Di modo che sono necessari come requisiti per l'esercizio
dell'azione: 1° Credito che l'azione deve proteggere.
2° Risultati dannosi. 3° Frode. 4° Atto che si
impugna.
Allo stesso modo, l'azione revocatoria fallimentare tende
a proteggere il creditore frodato dal debitore nel fallimento,
però partendo da presupposti diversi da quelli che
determinano l'azione pauliana. In questo caso non è
necessaria la frode, posto che il fallimento suppone l'insolvenza
del debitore e con quella si pretende stabilire la par condicio
creditorum. Così si richiede: 1°. La dichiarazione
formale dello stato di cessazione, realizzata nella sentenza
dichiarativa di fallimento o in altra sentenza successivamente.
2°. L'insufficienza del patrimonio (netto) del debitore
per soddisfare integralmente l'importo dei crediti fallimentari.
3°. L'esistenza di un determinato atto giuridico che la
Legge dichiara espressamente revocabile nell'interesse della
massa dei creditori.
Quindi, la chiamata revocatoria fallimentare rappresenta nel
nostro sistema giuridico l'esercizio di azioni di inopponibilità,
rispetto agli atti giuridici eseguiti dal debitore durante
il periodo sospetto, e che siano ritenuti fraudolenti o clandestini
secondo quanto stabilisce la Legge in quanto vanno in pregiudizio
della par condicio creditorum (4).
Di modo che la revocatoria si inquadra nel sistema giuridico
spagnolo grazie a tre elementi distinti, vale a dire:
a) alcuni atti vengono dichiarati nulli poiché compresi
nel periodo di retroattività della dichiarazione di
fallimento, fissato dal giudice, secondo il caso.
b) altri si ritengono inefficaci per essere stati realizzati
in determinati periodi anteriori alla dichiarazione di fallimento
che la Legge segnala.
c) e altri, anch'essi realizzati in determinati periodi di
tempo anteriori alla dichiarazione di fallimento, potranno
essere annullati previa prova che vi era intenzione di defraudare
i creditori.
In qualsiasi caso, dobbiamo sottolineare che la finalità
di questi istituti è indirizzata a reintegrare il patrimonio
- o impedire che non siano più in possesso - i beni,
crediti o i diritti che costituiscono la proprietà
del debitore e che costituiscono il pegno comune dei suoi
creditori.
In tal modo, il legislatore in difesa dei creditori permette
lo sviluppo dell'azione revocatoria fallimentare che implica
quanto segue:
1. INABILITAZIONE del fallito, per il solo fatto della dichiarazione
di fallimento da parte dell'amministrazione e disposizione
dei suoi beni (art. 878 Codice del Commercio).
2. RETROATTIVITA' degli effetti del fallimento fino al periodo
o al giorno in cui il fallito abbia smesso di pagare le sue
obbligazioni correnti. E, di conseguenza, annulla ipso iure
tutti i suoi atti di disposizione e amministrazione posteriori
a tale epoca (art. 872 paragrafo 2).
3. PERIODO SOSPETTO, significa che si parte dal presupposto
che anche prima della cessazione del pagamento corrente delle
sue obbligazioni il fallito attraversa un periodo anormale.
4. ATTI OGGETTO DELLA REVOCA, secondo quanto detto anteriormente,
la normativa fallimentare spagnola stabilisce in modo esaustivo
gli atti che, per essere eseguiti nel periodo supra menzionato,
non hanno efficacia rispetto ai creditori, o ipso iure (art.
879 e 880), o a richiesta dei creditori (art. 881 e 882),
tutti del Codice del commercio.
A)
LA RETROATTIVITA':
Dice il paragrafo 2° dell'art. 878 del Codice del Commercio
spagnolo: "utti gli atti di disposizione e amministrazione
(del fallito) successivi all'epoca rispetto alla quale retroagiscono
gli effetti del fallimento saranno nulli".
Si osserva che secondo il paragrafo 2° delll'art. 878
del Codice del commercio gli atti realizzati in pregiudizio
dei creditori saranno nulli (5). Risulta evidente, per tanto,
che la finalità della retroattività ha un'evidente
connessione con quella stabilita per il procedimento del fallimento
in generale, già che, come tutti sanno, si tratta di
assoggettare tutto il patrimonio del debitore a un procedimento
che permetta di soddisfare i crediti (6). Così la retroattività
implica la concorrenza di due requisiti: 1) la realizzazione
degli atti o contratti nel periodo di retroattività
e; 2) il suo carattere pregiudizievole per i creditori (7).
In tal modo il paragrafo 2° dell'art. 878 proclama la
nullità degli atti di disposizione e di amministrazione
successivi al periodo rispetto al quale retroagiscono gli
effetti del fallimento e il cui fondamento (8) si trova nel
non voler pregiudicare la massa generale dei creditori sia
sottraendo parte dei beni toccati dall'adempimento (9) delle
obbligazioni del debitore comune, sia stabilendo tra i creditori,
individualmente considerati, un trattamento diseguale, incompatibile
con la par condicio creditorum. Si capisce così come
questo procedimento riposi sulla non disgregazione del patrimonio
(10).
Così da un punto di vista processuale è nella
sentenza dichiarativa del fallimento che il Giudice può
dare o non dare alla stessa effetti retroattivi. Nel primo
caso fissa concretamente la data fino alla quale retroagiscono
gli effetti della dichiarazione e quindi, per applicazione
di quanto disposto dal testo (art. 878 già commentato),
tutti gli atti di amministrazione del fallito successivi a
tale data saranno nulli. Se la sentenza non stabilisce la
retroattività degli effetti del fallimento fino alla
data anteriore alla dichiarazione, la nullità solo
riguarderà gli atti posteriori a tale data. Gli atti
contemporanei alla data di retroattività o della dichiarazione
di fallimento devono ugualmente ritenersi nulli (si veda la
sentenza del 13 febbraio 1960).
Si tratta di una nullità assoluta o di pieno diritto,
che produrrà effetto rispetto a tutti (con indipendenza
dalla situazione di ignoranza o di buona fede nella quale
si trovi il terzo, secondo la sentenza del 21 maggio del 1960)
non avrà bisogno di essere chiesta né dichiarata
giudizialmente, e fa ritornare alla massa ipso iure quei beni
che uscirono dal patrimonio del debitore come conseguenza
di tali atti nulli (11).
Adesso, dobbiamo sottolineare che il Tribunale Supremo spagnolo
ha corretto (12) l'interpretazione letterale della nullità
assoluta che deriva dal precetto commentato, anche se con
alcune riserve già che l'idea centrale che giustifica
questa istituzione secondo l'Alto Tribunale deriva dal fatto
che ci troviamo di fronte ad una situazione di "ordine
pubblico" che appartiene ai precetti sostanziali e processuali,
che regolano il fallimento - e concretamente l'art. 878 del
Codice del commercio -, in difesa dei creditori e dell'economia
pubblica. In tal modo la giurisprudenza afferma che gli interessi
del fallimento devono prevalere in qualsiasi caso, evitando
l'ingiusto sgretolamento della massa in proximun tempus decoctionis.
Ciò nonostante, la sentenza del Tribunale Supremo del
12 marzo 1993 (13) (RA. 1793) rappresenta un cambiamento di
opinione dell'Alto Tribunale, in quanto segnala che la possibile
inefficacia radicale dell'articolo citato è suscettibile
di essere interpretata come relativa quando non si dimostra
che gli atti di disposizione o amministrazione realizzati
dal fallito pregiudicano la massa del fallimento. Con l'adozione
di questo nuovo criterio il Tribunale Supremo segue una dottrina
scientificamente fondata, che si realizza con la necessaria
apertura alla realtà dei tempi che già da tempo
in materia di retroattività si richiedeva (14).
B)
ATTI INEFFICACI IN RAGIONE ESCLUSIVA DEL PERIIODO IN CUI FURONO
REALIZZATI:
Per determinati atti realizzati in periodi anteriori molto
vicini alla dichiarazione di fallimento, la Legge stabilisce
una presunzione di frode e dichiara la loro inefficacia, permettendo
che possano essere impugnati dai sindaci in rappresentanza
dei creditori.
Da un lato, dichiara il Codice che "le quantità
che il fallito abbia soddisfatto in denaro, effetti o valori
di credito nei quindici giorni precedenti alla dichiarazione
di fallimento, per debiti e obbligazioni dirette la cui scadenza
sia posteriore allo stesso, saranno restituiti alla massa
da parte di coloro che le ricevettero", e che "lo
sconto dei suoi propri effetti, fatto dal commerciante entro
lo stesso periodo, si considererà come un pagamento
anticipato" (art. 879).
Secondo l'articolo 879 sono nulli: "I pagamenti anticipati
- in denaro, effetti o valori - di obbligazioni o debiti diretti,
incluse lettere di cambio, le cui scadenze siano posteriori
alla dichiarazione di fallimento, realizzati nei quindici
giorni precedenti alla dichiarazione di fallimento. Lo sconto
dei propri effetti fatto dal commerciante fallito nello stesso
periodo".
La distinzione che il legislatore stabilisce tra debiti scaduti
e non scaduti allo scopo di annullare il loro pagamento se
fosse anticipato o prossimo al fallimento, induce a sospettare
che il debitore abbia voluto migliorare la posizione di un
creditore di fronte ai restanti, frodando la par condicio
creditorum. E per ciò, senza ammissione di prova contraria,
per il solo fatto di anticipare il pagamento al fallimento,
e tenuto conto del periodo sospetto a cui si riferisce, insieme
ai trattati (15), il Tribunale Supremo nella sua sentenza
del 15 novembre 1928, insieme al legislatore annulla questi
pagamenti. Per lo stesso motivo, si annullano gli sconti fatti
dal debitore, già che il legislatore li equipara i
pagamenti anticipati.
Le conseguenze di queste nullità sono: 1° Che la
persona che ha riscosso anticipatamente il debito non scaduto,
restituirà quanto ricevuto al fallimento. 2° Che
la persona che scontò gli effetti del fallito, restituirà
questi effetti al fallimento 3° e che, naturalmente, queste
persone diventeranno creditori del fallito nel suo fallimento.
Tenuto conto, nonostante quanto disposto, da una parte, dell'articolo
14 della Legge "Cambiaria e del Cheque" del 1985
relativa alla trasmissione delle lettere di cambio con girata
e, dall'altra, dell'articolo 1307 del Codice civile sulle
conseguenze dell'annullamento quando la cosa da restituire
sia in possesso di terzi, riteniamo per quanto si riferisce
allo sconto degli effetti del fallito, che quando tali effetti
non possano essere restituiti al fallimento, dovrà
reintegrarsi il suo patrimonio, in contanti, al terzo o contrattante
che lo scontò al fallito.
D'altra parte, dobbiamo sottolineare che si reputano fraudolente
e inefficaci secondo l'art. 880, quando siano stati realizzati
nei trenta giorni precedenti alla dichiarazione di fallimento:
1. le trasmissioni di beni immobili a titolo gratuito;
2. le costituzioni in dote di beni propri alle proprie figlie;
3. i trasferimenti di beni immobili in pagamento di debiti
non scaduti al tempo della dichiarazione di fallimento;
4. le ipoteche sulle obbligazioni di data anteriore che non
abbiano questa qualità, e
5. le donazioni non remuneratorie.
La presunzione è iuris et de iure, non ammette prova
contraria (sentenza del 15 novembre 1928) ed esime i sindaci
dalla necessità di richiedere un giudizio dichiarativo
per riportare alla massa i beni oggetto di questi atti o contratti,
bastando in tal senso seguire il tramite del divieto (azione)
di riscossione (art. 1375 c.p.c.).
In definitiva, in relazione agli atti tassativamente stabiliti
dagli art. 879 e 880 del Codice di Commercio spagnolo dobbiamo
dire:
1 1 Che così come la nullità alla quale si riferisce
l'articolo 879 ha una base obiettiva (data del pagamento in
relazione alla sua scadenza e alla retroattività del
fallimento) quella fissata dall'articolo 880 ha una base soggettiva:
la fraudolenza. Per ciò l'articolo 880 designa gli
atti svolti con "consilium fraudis" o intenzione
di frodare in relazione all'alienazione, donazione, etc, quelli
svolti da colui che acquista i beni con intenzione di frodare.
2 Che gli atti nulli e inefficaci devono essere, in ogni caso,
volontari, o che è la stessa cosa, deve trattarsi di
negozi giuridici. Una cosa è che un bene qualsiasi
esca dal patrimonio del debitore a causa di un suo atto, determinante
o preparatorio - vendita, donazione, sequestro determinato
dall'accettazione di una lettera-, e un'altra cosa è
che sorga per forza di natura, estranea alla volontà
del fallito.
3 Che è indifferente che l'alienazione o diminuzione
patrimoniale si sia realizzata mediante operazioni o atti
di puro diritto privato - contratto - o con certi atti di
Diritto pubblico.
C)
ATTI ANNULLABILI PREVIA PROVA DELLA FRODE:
Sono quelli enumerati negli articoli 881 e 882. Dichiara l'articolo
881 del Codice del commercio: "potranno essere annullati
a richiesta dei creditori, mediante la prova del fatto che
il debitore procedette con l'intenzione di defraudare i loro
diritti". Mentre l'articolo 882 precisa che: "otrà
essere revocata su istanza dei creditori qualsiasi donazione
o contratto celebrato nei due anni anteriori al fallimento,
se si possa provare qualsiasi supposizione o simulazione fatta
in frode degli stessi".
In realtà, si tratta di presupposti di frode che anche
se non fossero raccolti dal Codice del commercio rientrerebbero
comunque nell'azione pauliana ordinaria degli articoli 1111
e 1292.3 del Codice civile. Ciò che fa il Codice del
commercio è fissare i periodi di tempo anteriori alla
dichiarazione di fallimento nei quali devono realizzarsi gli
atti affinché si possa procedere all'annullamento.
In generale e previa prova della frode, sono annullabili tutti
i contratti, obbligazioni e operazioni mercantili del fallito
che non siano anteriori di dieci giorni almeno alla dichiarazione
di fallimento; d'altra parte, le alienazioni di immobili a
titolo oneroso, le costituzioni di doti di beni della società
coniugale a favore delle figlie, o qualsiasi trasmissione
degli stessi beni a titolo gratuito, sono annullabili se furono
realizzati nel mese precedente, e le costituzioni di doti
o i riconoscimenti di capitali a favore dell'altro coniuge,
così come le dichiarazioni di ricevimenti di denaro
o effetti a titolo di prestito, quando siano stati fatti nei
sei mesi anteriori (art. 881). Però a parte questo,
"potrà essere revocato a richiesta dei creditori
qualsiasi donazione o contratto concluso nei due anni precedenti
alla dichiarazione di fallimento, se si dimostri qualsiasi
tipo di supposizione o simulazione fatta in frode degli stessi"
(art. 882) come dicevamo supra.
L'articolo precedente (882) del Codice di commercio, così
come i suoi precedenti 880 e 881, si riferisce a determinati
atti fraudolenti del fallito. Però si differenzia da
quelli per un elemento caratteristico: la simulazione o supposizione.
Per tanto solamente quando, oltre alla fraudolenza, e in relazione
ad essa, si provi, da parte di colui che impugna, la simulazione
che dimostri un'apparenza contrattuale distinta da quella
reale, si stabilirà la revocatoria prevista. La sola
simulazione o fraudolenza non bastano, devono essere presenti
congiuntamente entrambe (16).
Senza dubbio, come nei casi precedentemente esaminati, se
si ottiene la revoca di un qualsiasi atto simulato o supposto,
ritorneranno alla massa attiva del fallimento i beni che indebitamente
sono usciti da essa a causa degli atti revocati, o saranno
liberati da qualsiasi gravame che con tali atti siano stati
creati. E, allo stesso modo, non avranno efficacia i riconoscimenti
di crediti che non corrispondano alla realtà.
Gli atti toccati dall'annullabilità o nullità
relativa alla quale si riferiscono gli articoli 881 e 882
del Codice del commercio, sono realizzati fuori dai limiti
della retroattività, sebbene sempre all'interno del
così detto periodo sospetto, e per tanto di fronte
ad essi non si può allegare la indisponibilità
del patrimonio. Ciò, in teoria, induce a pensare che
i toccati dalla nullità possano intervenire nel fallimento.
E se si considera che, secondo il tenore degli articoli 881
e 882 del Codice del commercio, è sufficiente per dichiarare
la nullità che l'intenzione di frodare esista solo
nel fallito, è logico dedurre che, per quanto riguarda
i terzi che contrattarono con il fallito, gli effetti della
nullità saranno diversi a seconda del fatto che condivisero
o meno l'animus nocendi, ossia a seconda del fatto che vi
fosse o meno il consilium fraudis tra il debitore e il terzo.
In ogni caso, la nullità relativa, come quella assoluta,
comporta la restituzione alla massa dei beni che uscirono
dal patrimonio del debitore in ragione dell'atto annullato;
la liberazione degli oneri o gravami che si fissarono sopra
i beni del fallito, e l'inefficacia dei riconoscimenti di
credito o consegna dei beni (17).
D'altra parte, e per quanto riguarda i terzi che contrattarono
in buona fede, non c'è dubbio che possono intervenire
nel fallimento, partecipando alla divisione, allo stesso modo
dei restanti creditori del fallito. Ciò significa che
se i terzi hanno condiviso l'animus nocendi del fallito, hanno
dato vita a un consilium fraudis, per tanto si dovrà
negare loro il diritto di intervenire nel fallimento conformemente
a quanto dispone l'articolo 894 del Codice del commercio relativo
ai complici del fallito.
2.- CONCLUSIONI:
I tratti caratteristici della regolamentazione della revocatoria
spagnola che dobbiamo evidenziare sono:
Primo: La revocatoria spagnola contempla un sistema misto
composto dalla retroattività che presuppone la dichiarazione
di nullità (nullità assoluta) di tutti gli atti
anteriori alla dichiarazione di fallimento, dipendente dalla
data che fissa il Giudice nella sentenza dichiarativa.
Allo stesso tempo, si completa quanto detto anteriormente
con diverse nullità relative (annullabilità)
facendo riferimento ai casi specifici che si stabiliscono
ex lege data e in funzione del periodo di tempo nel quale
furono realizzati tali atti, dai 10 giorni fino ai due anni
precedenti alla dichiarazione di fallimento. Per questi atti
si deve provare che andarono in pregiudizio della massa e
del principio della par condicio creditorum.
Secondo: Il nostro sistema è molto rigoroso e risulta
conforme con la base e il principio ispiratore del nostro
procedimento concorsuale inteso nella sua finalità
liquidatrice e, allo stesso tempo, sanzionatrice della figura
del debitore. Sebbene sia certo che l'Alto Tribunale spagnolo
ha corretto nel tempo questo carattere, continuiamo a confrontarci
con questa filosofia rigida e poco realista (praticamente
già nell'anno 2000) che vuole punire e non avere fiducia,
ab initio, nella persona del debitore/commerciante.
3.- BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
ALCOVER GARAU, Guillermo. La retroacción de la quiebra.
Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 1996.
CANDELARIO MACÍAS, I.. El convenio de continuación
como medio de protección del crédito en los
procedimientos concursales. Granada: Comares, 1999.
MARCOS GONZÁLEZ, María. "El período
de retroacción en el proceso de quiebra". Nº.
3. Revista de Derecho Procesal Iberoamericano, 1995.p.897
e ss..
MASSAGUER FUENTES, J..La reintegración de la masa en
los procesos concursales. Barcelona, 1986.
RAMÍREZ, J.A. La Quiebra. Derecho Concursal español.
T. II. 2ª.ediz. Barcelona: Bosch, 1998. espec.p.1091
e ss.
ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A.. "Introducción
al sistema de reintegración de la masa de la quiebra".
Revista de Derecho Mercantil, 1979.p.37 e ss..
SANCHO GARAGALLO, Ignacio. La retroacción de la quiebra.
Pamplona: Aranzadi, 1997.
URÍA, R.. Derecho Mercantil. 24ª. ediz. Madrid:
Marcial Pons, 1997 e 28ª.ediz. 2000.
NOTE
1) Questo testo è l'intervento sposto nel Convegno di studio
su LA REVOCATORIA FALLIMENTARE OGGI, Siena, 15-16 ottobre
1999.
2)
URÍA, R.. Derecho Mercantil. Madrid: Marcial Pons, 1997.p.1055.
3)
Più informazione: GARCÍA VILLAVERDE, R.."La quiebra: fuentes
aplicables y presupuestos de su declaración". In Quaderni
di Diritto Giudiziale. Diritto Concorsuale (AAVV). Madrid:
Consejo General del Poder Judicial, 1992.p.273 e ss.. MASSAGUER
FUENTES, J..La reintegración de la masa en los procesos concursales.
Barcelona, 1986. ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A.. "Introducción al
sistema de reintegración de la masa de la quiebra". Rivista
di Diritto Mercantile, 1979.p.37 e ss..
4)
Ved. GARAGUSO, H.. Ineficacia Concursal. Nulidades, Revocatorias
e inaplicabilidad de normas o pactos lícitos. Buenos Aires:
Depalma, 1981.p.133.
5)
Si veda per tutti il contenuto degli art. 878 nº.2, 879 a
882 del C. di c. e art.1366 a 1377 del Codice di procedura
civile, la cui interpretazione è contenuta in diversa giurisprudenza:
STS. del 27 maggio 1960[RA.2061]; STS. 24 ottobre 1989[RA.6956];
STS. 19 dicembre 1991[RA.9405].
6)
GONZÁLEZ HUEBRA, P..Tratado de Quiebras. Madrid: 1856.p. 30,
sosteneva che"introducida la retroacción con el objeto de
evitar los fraudes que el quebrado pudiera cometer en provecho
suyo o de otros, perjudicando a sus acreedores legítimos,
produce el inconveniente gravísimo de embarazar el comerciante
que trata de utilizar su crédito en el momento que más lo
necesita, exponiéndolo a que se vea privado de los recursos
que le pudieran facilitar los prestamistas o los amigos que
fiaran en su honradez, en su pericia y capacidad, precisamente
cuando su situación reclama una protección más eficaz. Perjudica
de este modo no sólo al quebrado, sino también a sus acreedores,
que sin este incoveniente hubieran conseguido acaso cobrar
antes y por completo, y sobre todo al comercio en general
por la inseguridad que introduce, habiendo de quedar las operaciones
expuestas a invalidarse (...)". Anche, GARRIGUES,J.. Curso
de Derecho Mercantil.6ª.ediz.T. II.Madrid,1974.p.411 e ss.;
MARTÍN REYES, Mª. Angeles. La retroacción absoluta de la quiebra
y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pamplona: Aranzadi,
1995. p.44; BELTRÁN SÁNCHEZ, E.."Hipoteca, ejecución separada
y reintegración de la masa". T.III. En Estudios Jurídicos
en homenaje a A. Menéndez. Madrid: Cívitas, 1996.p.3493 e
ss.; ALCOVER GARAU, G.. La retroacción de la quiebra. Madrid:
McGraw-Hill, 1996.p.25 e ss.; MARCOS MADRUGA, Florencio. "Algunas
consideraciones sobre la retroacción de la quiebra: l'art.
878 del C. di c.". in Derecho Concursal I. Madrid: Quaderni
di DirittoGiudiziale, 1992. p.601 e ss.. SANCHO GARGALLO.
"Operaciones de reintegración de la masa de la quiebra". Diritto
Concorsuale II. Madrid: Quaderni di diritto giudiziale, 1997.
p.431 e ss..
7)Si
tenga presente la STS. del 25 maggio 1961[RA.2336]; STS. del
22 febbraio 1963[RA.1128] che dichiara che "la institución
de la retroacción (...) a fin de impedir las perniciosas consecuencias
que en los derechos de los legítimos acreedores pueda ocasionar
una anómala actuación aislada de alguno de éstos, su connivencia
o no con el quebrado, en su beneficio exclusivo y en perjuicio
de la masa". Nello stesso senso cfr., STS. 26 giugno 1982[RA.3442];
STS. 22 marzo 1985[RA.1198].
8)
Per questo aspetto sottolinea SANCHO GARGALLO, I.. La Retroacción
de la Quiebra. Pamplona: Aranzadi, 1997.p. 223 e 224, "si
en la mente del legislador aparece clara la finalidad común
de todas las operaciones de reintegración, con mayor nítidez
se observa en el sentido que la Ley toma hoy día. No existiendo
en la actualidad una obligación, por parte del comerciante
que cesa en el pago de sus obligaciones, de declararse en
quiebra, carece de fundamento la pretensión de trasladar los
efectos de una quiebra al momento en que supuestamente debía
haberse instado, si no es a los meros efectos de evitar fraudes
y perjuicios injustificados a los acreedores concursales.
La existencia de otras soluciones para la empresa en crisis
y la dificultad de concretar el momento exacto en que se cumplieron
los presupuestos objetivos de la quiebra muestran el verdadero
sentido de la retroacción".
9)
Si forma quindi una communio incidens pignoraticia. Deve restare
chiaro che in qualsiasi momento si deve tener presente, come
orientamento di carattere generale, il principio della responsabilità
patrimoniale universale del debitore che fissa l'art.1911
del C.c.:"del cumplimiento de sus obligaciones responde el
deudor con todos sus bienes presentes y futuros".Lo stesso
sostiene TORRES DE CRUELLS e MAS CALVET. La Suspensión de
Pagos. 2ª.ediz. Barcelona: Bosch,1995. p.393, "este principio
presupone que el deudor al obligarse, queda vinculado casi
físicamente al acreedor, porque los bienes de aquél son la
garantía de éste en una relación que será relativa y expectante
mientras que el deudor esté en condiciones económicas de poder
pagar (...)".
10)Si
tenga presente in questo punto la difficoltà esistente di
trovare la ragion d'essere che spinse il legislatore a stabilire
le misure che contengono nel nostro Diritto positivo la retroattività
e le azioni impugnatorie. In ogni caso è chiaro che la dichiarazione
giudiziale solitamente precede un periodo di incertezza economica
nella quale il debitore, vedendo già prossimo il fallimento,
cerca di ritardarlo con operazioni che al contrario molto
spesso lo accelerano. Si vuole porre l'attenzione sul fatto
che la precedente considerazione implica che il destino dell'impresa
sia la sua totale liquidazione. Di conseguenza, il debitore
cerca di salvare alcuni beni per sé e per le persone di sua
fiducia grazie a un procedimento di supposte alienazioni;
cerca quindi, di porre in una situazione privilegiata certi
creditori più vicini, e di soddisfare anticipatamente certi
crediti. Con questo comportamento tipico del periodo immediatamente
anteriore al fallimento, il debitore, si trova realmente in
uno stato di cessazione dei pagamenti, e pregiudica i suoi
creditori, sia perché sottrae beni alla garanzia comune, sia
perché vulnera il principio della uguaglianza di condizione
tra loro.
11)
Le sentenze del 7 marzo 1973 e del 26 marzo 1974 dichiarano
che, annulata una vendita per effetto della retroattività,
ritornano alla massa del fallimento i beni venduti senza che
l'amministratore restituisca al compretore il prezzo pagato;
però, in cambio, le sentenze del 20 maggio 1975, 10 marzo
e 15 ottobre 1976 e 12 novembre 1977 ritengono che il paragrafo
2º. dell'art 878 non raggiunge i presupposti tipici dello
sconto di lettere per entità di credito, né il gioco normale
dei conti correnti bancari, e per quanto riguarda gli effetti
della retroattività rispetto al terzo ipotecario, si vedano
le Risoluzioni della Direzione generale del Registro e del
Notariato del 20 gennaio 1986.
12)
Precisamente, contro questo carattere poco flessibile, si
pronuncia la STS. del 10 marzo 1976[RA.1176]; STS. del 15
ottobre 1976[RA.3960]; STS. del 12 novembre 1977[RA.4185];
STS. del 12 marzo 1993[RA.1793]; STS. del 20 settembre 1993[RA.6647]
dichiara che "se ha venido corrigiendo el rigor del texto
literal cuando los actos de transmisión o administración no
afecten o no sean contrarios a los intereses de los acreedores".
ST. della AP. di Barcelona del 10 giugno 1994[Ac.,núm.1043];
STS. del 16 marzo 1995[RA.3482]; STS. del 28 ottobre 1996[(Fd.
Jur.2)RA.7434]; STS. del 23 gennaio 1997[Ac., núm.152]; ST.
della AP. di Barcelona del 5 maggio 1997[Ac., num.1195]; ST.
della AP. delle Baleari del 19 gennaio 1998[Ac.num.208], in
cui si contempla l'attenuazione della rigorosità del precetto
in certi casi, così su Fd. Jur. 3, si afferma che "habiéndose
exigido la demostración del consilium fraudis en la persona
que contrata con el quebrado a quien debe serle acreditado
el animus fraudandi para declarar nulo el contrato inserto
en el período de retroacción absoluta (...)". Si aggiunge
nel Fd. Jur.4, "con dichos actos jurídicos se consiguió sustraer
o desviar la cantidad reclamada en beneficio del resto y comprometiendo
o infrigiendo el principio de la par condicio creditorum".
Si aggiungano, cfr., le parole Prof. ILLESCAS ORTIZ, R.."Apuntes
para una reforma del derecho concursal español". II Bollettino
dell'Illustre Collegio di Avvocati di Siviglia, gennaio-aprile,1977.
p.12, "la doctrina ha criticado duramente la solución normativa
y ha procurado atemperar las consecuencias rigurosas del párrafo
2 del art. 878, actividad ésta en la que se ha visto auxiliada
por una abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, la
cual, cediendo ante las ya mencionadas exigencias de justicia
material, ha utilizado con frecuencia expedientes de más que
dudosa validez y pulcritud técnico-jurídica".
13)Afferma
nonstante, la sentenza citata: "la inseguridad jurídica que
indudablemente produce la nulidad ipso iure de los actos afectados
por la retroacción no puede elevarse al rango de inconstitucionalidad
por atentar contra la tutela efectiva a la que tiene derecho
toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos
en cuanto que, aunque próxima a tal inconstitucionalidad,
ni desconoce el derecho de impugnar la fecha de retroacción,
al objeto de excluirla total o parcialmente, ni, en principio,
supone la pérdida de los derechos económicos derivados de
la referida nulidad".
14)
Commentata e spiegata da MARCOS GONZÁLEZ LECUONA, María. nel
"El período de retroacción en el proceso de quiebra". Nº.3.
Rivista di Diritto processuale, 1995.p.900 e ss..
15)
Ved. RAMÍREZ, J.A..La Quiebra. T.2. 2ª.ediz. Barcelona: Bosch,
1998.p.1221
16)RAMÍREZ,
J.A..La Quiebra. Op.cit.p.1245
17)
In linea di quanto disposto dagli articoli 1295 e 1303 del
Codice civile spagnolo.
|