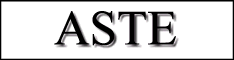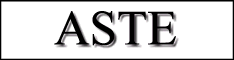Corte
di Cassazione, 10 marzo 2001 n. 3551, I dipendenti dell´impresa
possono ottenere dalla p.a. appaltante i compensi non pagati
dall´appaltatore, l´articolo 1676 del codice
civile si applica anche agli appalti di lavori pubblici
Secondo la presente sentenza, i lavoratori di un impresa
, possono conseguire dall'Amministrazione Appaltante, quanto
loro spettante e non pagato dall'Appaltatore fino alla scadenza
del debito che il committente ha verso l'appaltatore.
La corte di Cassazione , ha stabilito che l'articolo 1676
del codice civile va applicato anche negli appalti di lavori
pubblici, tale applicazione trova riscontro dall'art. 13
del Nuovo capitolato generale d'appalto Approvato con D.Min.
n. 145 del 2000, dove stabilisce che l'amministrazione può
pagare direttamente quanto spettante agli operai da parte
dell'appaltatore non corrisposto alle previste scadenze.
(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 10 marzo
2001, n. 3551– Ianniruberto, Presidente – Prestipino,
Relatore)
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro
Composta dagli Illi.mi Signori Magistrati: Dott. Giuseppe
Ianniruberto, Presidente Dott. Giovanni Prestipino, Consigliere,
Relatore Dott. Alberto Spanò, Consigliere Dott. Natale
Capitanio, Consigliere Dott. Raffaele Foglia, Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza n. 3559 depositata il
10.03.2001 sul ricorso n. 6816/2000 proposto da FALLIMENTO
della I. s.p.a., in persona del curatore, elettivamente
domiciliato in Roma, ... presso lo studio dell'Avv. F.P.,
che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine
del ricorso per cassazione, ricorrente,
contro
S.P., Z.B., M.R., I.R., P.L., T.M., L.F., S.M., V.G., S.S.,
elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio dell'Avv.
L.M., che le rappresenta e difende per procura speciale
a margine del controricorso, controricorrenti
e contro V.A.M., ed altri, Intimati,
e nei confronti di MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, domicilia pure per legge. controricorrente
e sul ricorso n. 9893/2000 proposto da MINISTERO DELLE FINANZE,
in persona del Ministro pro tempore, come sopra per legge
rappresentato, difeso e domiciliato, ricorrente incidentale
contro S.S., ed altri, Intimati
nei confronti di FALLIMENTO della I. s.p.a., intimato,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma
n. 25314 del 30.11.1999 (R.G. n. 48865/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 18.12.2000 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti l'Avv. F.P. per il fallimento e l'Avv. L.M. per
le lavoratrici resistenti; Sentito il P.M., nella persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti,
che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 31 luglio 1995 P.S. ed altri ventisei lavoratori,
convenivano davanti al Pretore del lavoro di Roma la I.
s.p.a., il Ministero delle Finanze e il CESID-Centro Servizi
Imposte Dirette e, premesso che erano stati dipendenti della
suddetta società e che con provvedimento del 20 luglio
1995 era stato dal medesimo Pretore autorizzato, a garanzia
di crediti da essi vantati (per retribuzioni, trattamento
di fine rapporto ed altri emolumenti inerenti al rapporto
di lavoro), un sequestro conservativo fino alla concorrenza
della somma di Lire 350.000.000 delle somme dovute dal Ministero
alla medesima società in relazione ad un contratto
di appalto di pulizie stipulato fra le parti, chiedevano
che i convenuti - la prima quale datrice di lavoro e gli
altri due quali committenti della società appaltatrice,
ai sensi dell'art. 1676 c.c. - fossero condannati a pagare
loro le somme per ciascuno di essi indicate, con interessi
legali e rivalutazione monetaria.
Rimasti contumaci i convenuti e assunta la prova testimoniale
dedotta dai ricorrenti, il Pretore con sentenza del 26 settembre
1996 condannava la società I. s.p.a. e il Ministero
delle Finanze a pagare, in solido, ai lavoratori le somme
indicate nel ricorso; la domanda proposta nei confronti
del CESID veniva invece disattesa, per essere il Centro
privo di autonoma soggettività giuridica.
Essendo stato nel frattempo dichiarato il fallimento della
società I. s.p.a. (con sentenza del 21 marzo 1996),
la pronuncia emessa dal Pretore veniva impugnata sia dal
Ministero delle Finanze che dal curatore del fallimento.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, con
sentenza del 30 novembre 1999, in parziale riforma della
decisione impugnata "precisava in Lire 352.431.335
la somma massima dovuta dal Ministero" e dichiarava
l'improcedibilità della domanda proposta dai lavoratori
contro il fallimento.
Il giudice di appello osservava:
1) che l'azione diretta dei lavoratori contro il committente
dell'appaltatore-datore di lavoro, prevista dall'art. 1676
c.c., è sottratta alle vicende del rapporto di appalto
perché compete ai suddetti lavoratori in base ad
un titolo proprio, con la conseguenza che la stessa non
é preclusa dalla dichiarazione di fallimento dell'appaltatore;
2) che l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società
I. s.p.a. non poteva avere conseguenze sul sequestro, a
suo tempo autorizzato dal Pretore di Roma, delle somme dovute
alla società dal Ministero delle Finanze, sia perché
nell'attuale ordinamento processuale non è più
previsto l'istituto della convalida, sia perché il
sequestro perde efficacia nel momento in cui il creditore
ha ottenuto una sentenza esecutiva per legge; 3) che il
Ministero non poteva invocare l'art. 351 della l. 20 marzo
1855 n. 2249 all. F, non essendo questa disposizione di
legge applicabile alla domanda proposta in base all'art.
1676 c.c. e, inoltre, avendo il medesimo Ministero posto
in essere un appalto per la cui esecuzione non era stata
prevista l'attività di collaudo; 4) che risultava
provato, per mezzo dei documenti prodotti in giudizio dallo
stesso Ministero delle Finanze, il contratto di appalto
stipulato fra quest'ultimo e la società I. s.p.a.;
5) che la sentenza di condanna nei confronti del Ministero
non poteva essere subordinata all'espletamento delle procedure
contabili, dato che, altrimenti, l'amministrazione sarebbe
stata arbitra di stabilire l'epoca e, anche, l'ammontare
del pagamento; 6) che dai documenti acquisiti al giudizio
e dalla prova testimoniale era risultato che tutti i lavoratori,
che avevano promosso l'azione contro il Ministero delle
Finanze, avevano svolto attività lavorativa presso
i locali del medesimo Ministero in esecuzione del contratto
di appalto stipulato dalla società loro datrice di
lavoro, mentre nessuna censura era stata mossa alla decisione
con la quale il primo giudice aveva determinato le somme
spettanti a ciascun lavoratore; 7) che l'eccezione di compensazione
era stata tardivamente ed inammissibilmente dedotta dal
Ministero delle Finanze solamente con l'atto di appello;
8) che, non avendo il primo giudice a ciò provveduto,
era necessario precisare che "l'importo massimo al
cui pagamento era tenuta l'amministrazione", come dalla
stessa indicato, doveva essere determinato nella somma di
Lire 352.431.335.
Questa sentenza è stata impugnata per cassazione
dal fallimento della società I. s.p.a. con tre diversi
motivi e dal Ministero delle Finanze con due distinti e
complessi motivi.
Hanno resistito con controricorso al ricorso proposto dal
fallimento P.S., ed altri. Gli altri lavoratori non hanno
svolto attività difensiva. Il fallimento della società
I. s.p.a. e le controricorrenti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.,
la riunione del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze
a quello formulato dal fallimento della società I.
s.p.a., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
Sempre in via preliminare, poi, va rilevato che il Ministero
delle Finanze ha proposto il ricorso non già contro
l'impugnante principale (il fallimento della società
I. s.p.a.), ma contro i lavoratori: trattasi, quindi, di
impugnazione incidentale autonoma, proposta, ai sensi dell'art.
333 c.p.c., contro soggetti diversi da quello che aveva
formulato il ricorso principale e ammissibile in quanto
notificata nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
Ciò premesso, per ragioni di connessione vanno esaminati
i motivi primo e secondo dell'impugnazione proposta dal
fallimento e il primo motivo (indicato con i numeri 1 e
2) del ricorso formulato dal Ministero.
Entrambi i ricorrenti, nel denunciare la violazione e la
falsa applicazione dell'art. 1676 c.c., in relazione all'art.
51 della legge fallimentare, nonché vizi di motivazione
su punti decisivi della controversia con riferimento all'art.
360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c., lamentano che il Tribunale
non abbia dichiarato, a causa dell'intervenuto fallimento
della società I. s.p.a., l'improcedibilità
dell'azione promossa dai lavoratori contro il Ministero
delle Finanze. I due ricorrenti, al riguardo, deducono:
a) che il giudice di appello, nell'affermare che l'azione
di cui all'art. 1676 c.c. è autonoma e diretta e
si sottrae alle vicende economiche dell'appalto, non ha
tenuto conto del principio generale secondo cui, una volta
aperto il procedimento fallimentare, deve essere attuato
il concorso di tutti i creditori; b) che il Tribunale, nell'aderire
alla interpretazione data alla disposizione di legge dalla
Corte di cassazione nella sentenza n. 4051 del 10 luglio
1984, non ha considerato gli effetti che, in base a tale
interpretazione, si produrrebbero in capo agli altri creditori
della società I. s.p.a., pure ammessi al passivo
del fallimento, i quali vedrebbero sottratta all'esecuzione
concorsuale una parte del patrimonio della società;
c) che, in particolare, rispetto agli attuali intimati (i
quali vedrebbero soddisfatte le loro pretese con la somma
dovuta alla società I. s.p.a. dal Ministero delle
Finanze), riceverebbero una minore tutela, e quindi una
evidente disparità di trattamento, sia coloro che
non hanno la qualità di lavoratori subordinati, sia
coloro che, pur potendo basare la loro pretesa sul rapporto
di lavoro instaurato con la società I. s.p.a., non
hanno tuttavia proposto alcuna azione contro il Ministero
(e, fra questi ultimi, vi sono tanto quelli che non potevano
far valere alcun titolo nei confronti del Ministero per
non avere mai svolto attività lavorativa in esecuzione
del contratto di appalto per cui è causa, quanto
quelli che, pur essendovi legittimati, erano rimasti inerti);
d) che, pur essendo esatta la premessa dalla quale la decisione
impugnata ha preso le mosse, e cioè che l'azione
prevista dall'art. 1676 c.c. è diretta e, quindi,
diversa dall'azione surrogatoria - in quanto i lavoratori
agiscono in nome proprio, nel proprio interesse e nell'esercizio
di un diritto proprio (tesi, codesta, sostenuta nella suddetta
sentenza della Corte di Cassazione n. 4051 del 10 luglio
1884) - tuttavia è errata la conclusione che ne è
stata tratta, dato che l'azione non può sopravvivere
al fallimento dell'appaltatore-datore di lavoro per il semplice
fatto che i lavoratori, i quali possono agire, in base ad
uno ius exigendi in rem propriam, solamente fino a concorrenza
del debito del committente verso l'appaltatore e che sono
esposti alle medesime eccezioni proponibili contro l'appaltatore,
non vantano alcun credito direttamente nei confronti del
suddetto committente; e) che, venendo il credito dei lavoratori
soddisfatto mediante l'attribuzione ai medesimi del credito
dell'appaltatore, con una modificazione soggettiva del rapporto
obbligatorio inizialmente sorto fra gli altri due soggetti,
l'azione, nonostante sia esercitata nelle forme del processo
di cognizione, ha intrinseca natura esecutiva, giacché
solamente per mezzo del processo viene soddisfatto l'interesse
dei dipendenti con la contestuale estinzione del credito
dell'appaltatore verso il committente e con il sorgere di
un vincolo di solidarietà passiva fra questi due
soggetti verso i lavoratori; f) che, pertanto, essendo lo
strumento predisposto dalla legge identico al pignoramento
eseguito dai lavoratori sul credito vantato dall'appaltatore
nei confronti del committente, pure identici debbono considerarsi
gli effetti, derivando sia dalla sentenza che conclude il
giudizio promosso dai lavoratori ex art. 1676 c.c., sia
dall'assegnazione, costituente il provvedimento finale del
procedimento esecutivo, il soddisfacimento delle ragioni
dei lavoratori; g) che, d'altra parte, la ratio della disposizione
di cui al suddetto art. 1676 c.c. risiede nella esigenza
di attribuire ai dipendenti dell'appaltatore un meccanismo
più rapido per il soddisfacimento delle pretese vantate
verso il datore di lavoro, dato che don tale meccanismo
è consentita la contemporaneità, in un unico
processo, fra l'accertamento del credito dei lavoratori
e l'esecuzione, con la già rilevata sostanziale identità
dei due risultati finali; h) che, per queste ragioni, si
deve ritenere che l'azione ex art. 1676 c.c., inerente ad
un elemento esistente nel patrimonio del datore di lavoro
al momento della dichiarazione di fallimento del medesimo,
abbia la medesima natura esecutivo- satisfattiva del pignoramento
presso terzi, con la conseguenza, come si deve parimenti
ritenere, che dall'apertura del procedimento fallimentare,
nel quale deve essere garantita la par condicio fra tutti
i creditori, deriva l'improcedibilità sia dell'una
che dell'altra azione; i) che, se non si dovesse condividere
questa conclusione e si volesse seguire l'interpretazione
data alla norma dal Tribunale (nonché dalla suddetta
sentenza n. 4051 del 10 luglio 1984 della Corte di Cassazione),
la norma stessa sarebbe costituzionalmente illegittima,
per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, a causa della
diversa tutela che deriverebbe ai dipendenti dell'appaltatore
a seconda che costoro o agiscano verso il committente ex
art. 1676 c.c. o tentino di realizzare il loro credito,
portato da un titolo esecutivo, procedendo al pignoramento
presso terzi del credito dell'appaltatore o procedano al
sequestro conservativo di tale credito; l) che, al riguardo,
sarebbe manifesta l'irrazionalità della disposizione
perché, a seconda dello strumento prescelto in relazione
alle individuali posizioni dei singoli lavoratori, si determinerebbe
una tutela mero incisiva per coloro che vantano crediti
certi verso l'appaltatore (e che iniziano un'azione esecutiva
sulla base di tale posizione) rispetto a quelli che sono
titolari di un credito non ancora accertato, i quali, agendo
nei confronti del committente, vedono realizzata in pieno
la loro pretesa, completa di rivalutazione monetaria fino
al pagamento e non fino al giorno del deposito dello stato
passivo; m) che, infine, secondo il Ministero delle Finanze,
alcuni fra gli attuali intimati (R.G., A.M.T., A.V., R.I.,
F.L. e F.M.) "non avevano mai prestato attività
di servizio di pulizia nei locali di proprietà, dell'Amministrazione
finanziaria".
A parte la censura indicata con la lettera m) - che è
pure infondata, ma che pone una diversa questione tutte
le altre censure, che soprattutto dalla difesa del fallimento
sono state esposte con argomenti di rimarchevole pregio
sul piano formale, riflettono tesi dottrinarie, minoritarie
in ordine alla interpretazione dell'art. 1676 c.c., che
la Corte non ritiene di condividere, intendendo, viceversa,
aderire alle ragioni addotte, a fondamento della opposta
interpretazione, sia dalla prevalente dottrina, sia dalla
giurisprudenza.
L'art. 1676 c.c. - il quale, come è stato rilevato
in dottrina, trae origine da norme dettate nel vecchio ordinamento
francese e poi trasfuse, prima, nel codice napoleonico del
1805 e, poi, nel codice civile del 1865 (art. 1645, che
approntava una tutela a favore dei soli prestatori d'opera
manuale) - stabilisce che coloro che hanno svolto attività
lavorativa alle dipendenze dell'appaltatore nell'esecuzione
di un'opera o nella prestazione di un servizio dal medesimo
acquisiti possono agire contro il committente "per
conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza
del debito che il committente ha verso l'appaltatore al
tempo in cui essi propongono la domanda".
Dal contenuto della norma si evince che elementi dell'azione
sono:
1) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (art.
2094 c.c.) alle dipendenze di un imprenditore che, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita
urla attività diretta al compimento di un'opera o
di un servizio nei confronti di un determinato committente
verso un corrispettivo (art. 1655 c.c.); 2) l'esecuzione
della prestazione lavorativa per il rompimento di quella
particolare opera o di quello specifico servizio commissionati
da quel determinato committente; 3) l'esistenza di un credito
di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da
parte dell'appaltatore-datore di lavoro (artt. 2099 e segg.
c.c.); 4) in pari tempo, l'esistenza di un credito dell'appaltatore
verso il committente in relazione al compimento dell'opera
o del servizio commissionatigli (art. 1657 c.c.).
Ricorrendo tutti questi elementi, la legge prevede che i
lavoratori, mediante l'esercizio di un'azione contro il
committente, possono conseguire direttamente da quest'ultimo
la minor somma fra quella che è loro dovuta in conseguenza
del rapporto di lavoro e quella che è dovuta all'appaltatore
dal medesimo committente in relazione al contratto di appalto
stipulato dalle parti.
Ora, come ormai pacificamente si ammette dalla dottrina
- a superamento di una concezione che inizialmente era stata
sostenuta nella vigenza del codice civile del 1865 - il
fatto stesso che la legge parli di "azione diretta
contro il committente" e che la legittimazione attiva
sia attribuita ai lavoratori "per conseguire quanto
è loro dovuto", sta a significare che si verte
in un'ipotesi diversa da quella prevista dall'art. 2900
c.c. Al contrario dell'azione surrogatoria - che è
caratterizzata dalla sostituzione del creditore al proprio
debitore per far valere un diritto appartenente a quest'ultimo
e per ottenere che il bene oggetto del giudizio possa rientrare
nel patrimonio del soggetto sostituito - con l'azione prevista
dall'art. 1676 c.c. i lavoratori fanno valere un diritto
proprio, che la legge loro riconosce non in sostituzione
del loro debitore, ma direttamente: tanto è vero
che, come è stato precisato in dottrina, "gli,
effetti economici dell'azione si trasmettono automaticamente
nella sfera giuridica degli ausiliari" e non nel patrimonio
dell'appaltatore.
Di tal che, non diversamente da quanto accade in tutte le
ipotesi nelle quali la legge prevede che da parte di un
determinato soggetto possa essere promossa un'azione diretta
contro un altro soggetto anche in assenza di un originario
rapporto (sussistendo un diverso collegamento, operante
tramite un terzo soggetto) (cfr., ad esempio, l'art. 1717,
quarto comma, c.c., relativo al rapporto fra il mandante
e la persona sostituita dal mandatario nonché l'art.
1595, primo comma, c.c., inerente al rapporto fra il locatore
e il subconduttore), dal tenore della norma contenuta nell'art.
1676 c.c. risulta che, venuti in essere tutti gli elementi
sopra indicati, necessari per il sorgere della fattispecie,
immediatamente si determina la nascita di un rapporto diretto
fra i lavoratori e il committente, che si aggiunge, sovrapponendosi,
all'originario rapporto e che impedisce a quest'ultimo,
una volta che il committente ne sia stato reso edotto tramite
la domanda rivoltagli, di spiegare l'efficacia sua propria
(ciò in vista della sua definitiva estinzione, i
cui effetti si consumano con il pagamento eseguito ai lavoratori).
Come è stato osservato in dottrina, infatti, dal
giorno in cui è proposta la domanda (che non è
necessariamente quella giudiziale) e fino a quello del definitivo
pagamento, all'iniziale rapporto di credito fra l'appaltatore
e il committente si affianca un nuovo e connesso rapporto,
quello fra gli ausiliari dell'appaltatore e il committente:
soggetto, quest'ultimo, che per espressa volontà
della legge diventa diretto debitore dei lavoratori (come
garante ex lege, come si afferma da taluno, o in virtù
di un accollo ex lege, come si sostiene da altri) in aggiunta
all'appaltatore-datore di lavoro, unico originario debitore.
La previsione di questo particolare meccanismo, come è
stato osservato dalla dottrina, ha fondamento in una finalità
di natura preminentemente sociale, dato che il legislatore
ha voluto predisporre uno strumento che è rivolto
a tutelare una categoria di soggetti particolarmente deboli,
come sono i lavoratori subordinati, per preservarli dal
rischio dell'inadempimento o, peggio ancora, dell'insolvenza
del datore di lavoro e che va equiparato, attesa la sud
caratteristica collegata alla peculiare funzione, a quelle
figure giuridiche, come i privilegi, che sono automaticamente
destinate dalla legge a rafforzare, per coloro che si trovano
in una determinata situazione, la garanzia generica che
tutti i creditori hanno sul patrimonio del loro debitore.
Ratio della disposizione di legge è, quindi, non
tanto quella delineata nel presente giudizio dalla difesa
del fallimento - la quale, come si è visto, fa riferimento
all'esigenza di attribuire ai dipendenti dell'appaltatore
un mezzo più rapido per il soddisfacimento delle
loro pretese, sostenendo che tale esigenza sarebbe realizzata
mediante l'attuazione del principio di "contemporaneità"
fra l'accertamento del credito e la successiva esecuzione
- quanto quella di garantire agli ausiliari dell'appaltatore,
proprio in relazione ad una attività lavorativa prestata
per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati al
loro datore di lavoro, il pagamento della retribuzione dovuta
per quella determinata attività, in modo da sottrarre
il soddisfacimento del relativo diritto al rischio dell'insolvenza
del debitore.
Del resto, come pure é stato sottolineato dalla dottrina,
la possibilità offerta dalla legge ad una determinata
categoria di lavoratori - quelli che hanno prestato la loro
attività per quel determinato appalto e nell'interesse
di colui che lo ha commissionato - con l'attribuzione ai
medesimi di un'azione eccezionale, che permette di soddisfare
il credito vantato verso il datore di lavoro mediante il
diretto pagamento eseguito dal committente (e senza necessità
di far transitare nel patrimonio dell'appaltatore le somme
a questi dovute), trova giustificazione proprio nel beneficio
che il committente trae dai risultati conseguiti dallo svolgimento
di quella particolare attività.
Il che implica, per un verso, che l'appaltatore, dopo la
richiesta rivolta dai suoi ausiliari al committente, non
può pretendere da questo l'adempimento (né
può promuovere nei confronti del medesimo l'esecuzione
forzata qualora fosse già munito di un titolo esecutivo)
e, per un altro verso, che gli altri creditori dell'appaltatore,
che pure hanno la possibilità di soddisfarsi sulle
somme dovute dal committente previo esercizio dell'azione
surrogatoria, tuttavia perdono questa facoltà qualora
da parte degli aventi diritto sia stata già esercitata
l'azione di cui si discute. Si consideri, d'altra parte,
quanto sopra è stato già rilevato, e cioè
che il pagamento fatto dal committente agli ausiliari dell'appaltatore
ai sensi dell'art. 1676 c.c. estingue, in corrispondenza
della somma versata, sia il debito del medesimo committente
verso l'appaltatore, sia il debito di quest'ultimo verso
i lavoratori.
Questi principi ricevono applicazione anche nel caso della
dichiarazione di fallimento dell'appaltatore-datore di lavoro.
Posto che l'esercizio dell'azione da parte degli ausiliari
impedisce qualsiasi altra iniziativa individuale - non importa
se proveniente dall'appaltatore o dagli altri suoi creditori
e senza che possa avere rilievo il mezzo processuale impiegato
alle stesse conclusioni deve pervenirsi qualora intervenga
il fallimento dell'appaltatore, l'esecuzione collettiva
non differendo, quanto alla natura e ai limiti che incontra,
da quella individuale. E si deve, quindi, affermare che,
ai fini di cui si discute, l'apertura del procedimento concorsuale
non può incidere sulla posizione di quei lavoratori
che hanno già esperito l'azione prevista dalla norma
di legge in esame, giacché, se si ritenesse il contrario,
si finirebbe con il disconoscere la concreta finalità
perseguita dalla legge; sicché, dovendosi escludere
che il soddisfacimento delle pretese vantate dagli altri
creditori possa essere conseguito con nocumento delle ragioni
di quei lavoratori che hanno prestato la loro attività
per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati e che
fanno affidamento sulle somme dovute dal committente per
tale esecuzione si deve asserire che, se l'azione sia stata
già promossa, non ricorre nei confronti della stessa
alcun profilo di improcedibilità.
D'altra parte, se si tiene conto del fatto che l'azione
ex art. 1676 c.c., che è, per espressa previsione
di legge, diretta, incide, in quanto tale, direttamente
sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente
su un credito del debitore fallito (del quale, proprio a
causa di niella azione, è impedito il realizzo),
si comprende come l'apertura del procedimento fallimentare
non possa spiegare effetti sulle ragioni vantate dai lavoratori;
e non vale, per conseguenza, invocare gli artt. 51 e 52
del r.d. 16 luglio 1942, n. 267, essendo del tutto estranea
al fallimento una iniziativa già intrapresa da una
particolare categoria di creditori (ai quali dalla legge
è accordata una specifica tutela) e tendente al conseguimento
di una somma che, non essendo stata ancora corrisposta all'originario
creditore, fa parte del patrimonio non già del datore
di lavoro fallito, ma del committente (il quale, come é
stato sottolineato dalla dottrina, è terzo rispetto
al fallimento).
Ai risultati interpretativi finora esposti è già
pervenuta questa Corte della sentenza n. 4051 del 10 luglio
1984, indicata dai ricorrenti. In tale sentenza, a conclusione
delle argomentazioni svolte per individuare la natura dell'azione
prevista dall'art. 1676 c.c., é stato affermato che
"l'apertura del procedimento concorsuale non può
precludere l'esperimento di una azione tra terzi. espressamente
accordata dalla legge"; ed è stato aggiunto
che, se è vero che l'art. 52 della legge fallimentare
- che va letto in unione con il precedente art. 51, dettato
per le azioni esecutive - apre il concorso dei creditori
sul patrimonio del fallito, impedendo l'esercizio di azioni
proposte contro quest'ultimo in sedi diverse da quelle sue
proprie, è altrettanto vero che uguale effetto il
medesimo articolo di legge non può avere "per
le azioni autonome tra terzi, quali l'ausiliario e il committente",
in relazione a somme di danaro che, prima dei pagamento,
ancora si trovano nel patrimonio del committente. Conclusioni,
codeste, che sono state poi riprese da questa Corte in successive
pronunce, nelle quali, allo scopo di determinare la competenza
del giudice del lavoro nella controversia promossa dai lavoratori
contro il committente, è stato sostenuto che l'azione
"è del tutto autonoma da quella esperibile nei
confronti dell'appaltatore-datore di lavoro e può
dunque esplicarsi davanti al giudice del lavoro anche in
caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultimo" (Cass.
24 ottobre 1996 n. 9303, Cass. 14 maggio 1998 n, 4897 e
Cass. 14 dicembre 1998 n. 12551; cfr. in precedenza anche
Cass. 6 giugno 1983 n. 3855).
Dai rilievi fin qui esposti deriva che il sospetto di incostituzionalità
dell'art. 1676 C.C. nell'interpretazione che ne è
stata data dal Tribunale, prospettato dalla difesa del fallimento
ricorrente, non ha ragion d'essere.
Considerato che l'art. 3 della Costituzione nella lettura
fattane dalla suddetta difesa in corrispondenza con il principio
della par condicio creditorum che presiede le procedure
esecutive concorsuali - non può ritenersi violato
in presenza di situazioni disomogenee che giustificano una
differente disciplina (causata da una precisa scelta di
politica legislativa adottata dal legislatore) e considerato,
quindi, che la ricorrenza di tali situazioni non può
determinare alcun profilo di irrazionalità nel significato
dato ad una disposizione di legge, é a dirsi che
proprio l'interpretazione data alla norma dalla dottrina
prevalente e dalla giurisprudenza conforme ai principi fondamentali
del nostro ordinamento in tema di tutela del lavoro, in
tutte le sue articolazioni, quali si desumono dagli artt.
4, 35 e 36 della Costituzione; con la conseguenza che la
questione di legittimità costituzionale dedotta dal
fallimento della società I. s.p.a. deve essere dichiarata
manifestamente infondata, non essendo irrazionale una norma
che accorda uno specifico beneficia a determinati lavoratori,
anche rispetto ad altri, in relazione alla attività
lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro
soggetto (il committente, parte del contratto di appalto
stipulato con il loro datore di lavoro) ha ricavato un particolare
vantaggio.
Le argomentazioni finora svolte, unitariamente considerate,
esimono la Corte dal confutare singolarmente tutte le censure
dedotte nei due ricorsi sopra indicate con le lettere da
a) ad l). Qui va solamente aggiunto che l'articolata conclusione
alla quale si perviene in entrambi i ricorsi - la necessità
che sia attuato, a causa della dichiarazione di fallimento
dell'appaltatore, il concorso di tutti i creditori, l'impossibilità
che sia sottratta all'esecuzione concorsuale una parte del
patrimonio della società, la pretesa natura esecutiva
dell'azione prevista dall'art. 1676 c.c. (la quale, come
tale, non potrebbe sopravvivere al fallimento), il fatto
che i lavoratori possono ottenere dal committente il pagamento
di somme il cui ammontare non superi il credito vantato
dall'appaltatore - e frutto di uria non corretta premessa,
giacché ambedue i ricorrenti, pur affermando di voler
aderire alla tesi secondo cui l'azione accordata dalla legge
ai lavoratori, al contrario di quanto è previsto
per l'azione surrogatoria, è diretta e autonoma,
poi mostrano, in concreto, di dissentirne, come è
prova la proposizione, esposta in entrambi. i ricorsi, secondo
cui la domanda degli ausiliari dell'appaltatore contro il
committente determina le medesime conseguenze del pignoramento
presso terzi del credito del datore di lavoro. Con tale
proposizione, infatti, si trascura di considerare che il
diritto riconosciuto dalla legge ai lavoratori, ricorrendo
tutte le condizioni contemplate dalla legge, sorge in capo
ai medesimi lavoratori, per affiancarsi, allo scopo di sostituirlo
nel momento in cui é eseguito il pagamento, al diritto
che già esiste in capo all'appaltatore; e, inoltre,
si finisce con il confondere l'azione esecutiva - che viene
promossa, anche presso terzi, su un elemento attivo del
patrimonio del datore di lavoro e che resta travolta dal
fallimento del debitore - con l'azione di cognizione attribuita
a determinati soggetti, nei confronti di un terzo, per l'accertamento
di un diritto che è loro direttamente riconosciuto
dalla legge.
Resta, infine, da esaminare l'ultima censura (indicata con
lettera m) dedotta dal Ministero delle Finanze, con la quale
quest'ultimo sostiene, come si è detto, che alcune
delle lavoratrici che hanno proposto l'azione ex art. 1616
c.c. non avrebbero "mai prestato attività di
servizio di pulizia nei locali di proprietà dell'amministrazione
finanziaria".
Per disattendere anche questa censura, basta, da un lato,
richiamare l'accertamento compiuto nella sentenza impugnata,
nella quale è stato affermato che la prova della
"prestazione dell'attività lavorativa presso
il Ministero da parte degli appellati" era emersa dai
documenti prodotti in giudizio e, soprattutto, dalla deposizione
della teste Viventi, funzionaria della medesima amministrazione;
e, dall'altro, rilevare che, a fronte di siffatto accertamento,
il ricorrente, lungi dal precisare, in concreto, il vizio
di omessa o insufficiente motivazione (con l'indicazione
di risultanze probatorie non valutate o insufficientemente
valutate), si limita a fornire un apprezzamento delle prove
diverso da quello compiuto dal giudice di appello.
Ciò posto, passando all'esame del terzo motivo del
ricorso proposto dal fallimento. quest'ultimo, nel denunciare
la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2906 c.c.,
686 c.p.c., 42 e 51 della legge fallimentare, oltre al vizio
di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia
(art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.), sostiene che il
Tribunale non avrebbe dato adeguata risposta alle censure
(dedotte nell'atto di appello) inerenti al provvedimento
di sequestro del credito vantato dalla società I.
s.p.a. verso il Ministero delle Finanze, chiesto dai lavoratori
ed autorizzato dal Pretore di Roma prima dell'inizio del
presente giudizio.
Il ricorrente, in particolare, sottolinea che dal provvedimento
autorizzativo del sequestro era derivato un vincolo di indisponibilità
sulle somme dovute dal Ministero all'appaltatore, con la
conseguenza che, una volta dichiarato il fallimento del
debitore, le somme sequestrate, essendo confluite automaticamente
nella procedura concorsuale, non potevano essere attribuite
ai creditori sequestranti.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Dalle scarne indicazioni fornite dalle parti e dalle altrettanto
scarne argomentazioni subite sul punto nella sentenza impugnata,
non si riesce compiutamente a comprendere se il provvedimento
di sequestro conservativo sulle somme dovute alla società
I. s.p.a. dal Ministero delle Finanze fosse stato autorizzata
(prima dell'inizio della causa di merito, come è
pacifico) a favore dei lavoratori in relazione al credito
diretta dagli stessi vantato nei confronti del medesimo
Ministero in base all'art. 1676 c.c. - sicché, in
tal caso, si sarebbe trattato di un sequestro, su beni mobili,
presso il debitore - o se, viceversa (come è più
plausibile), il provvedimento del giudice avesse avuto per
oggetto il credito della società I. s.p.a. nei confronti
dell'amministrazione finanziaria.
Ricorrendo questa seconda ipotesi, peraltro, non viene chiarito
se fosse stata posto in essere lo Speciale procedimento
prevista dalla legge per il sequestro presso terzi e, in
particolare, se il Ministero delle Finanze avesse, o no,
reso la prescritta dichiarazione a norma dell'art. 543 e
segg. c.p.c., richiamati dal successivo art. 678 (v., in
particolare, l'art. 598 c.p.c., relativo alla mancata comparizione
del terzo o al rifiuto di questo a rendere la dichiarazione
o alla eventualità che sulla dichiarazione sorgano
contestazioni).
In questa situazione di evidente incertezza, le censure
dedotte dai fallimento ricorrente non possono trovare accoglimento.
Qualora si fosse realizzata la prima delle due ipotesi sopra
delineate (il sequestro presso il debitore-Ministero delle
Finanze di beni mobili di proprietà del medesimo),
la decisione emessa dal Tribunale dovrebbe rimanere ferma,
perché, una volta che sono stati accertati (e liquidati)
i crediti fatti valere dai lavoratori direttamente nei confronti
dell'amministrazione convenuta, é evidente che la
conseguenza non potrebbe che essere quella individuata nella
sentenza, impugnata, essendoti il sequestro convertito in
pignoramento, a norma dell'art. 686 c.p.c., in danno del
debitore nel momento in cui è stata emessa la sentenza
di condanna, esecutiva, a conclusione del giudizio di primo
grado.
Al contrario, se si fosse realizzata la seconda eventualità
(il sequestro di un credito della debitrice società
I. s.p.a., nei confronti del terzo Ministero delle Finanze),
a parte che, come è stato sopra esposto, manca in
causa qualsiasi indicazione per stabilire se la misura cautelare
fosse stata legittimamente eseguita (e il relativo procedimento
portato a compimento), non si sarebbe realizzata alcuna
possibilità di conversione del sequestro in pignoramento,
dato che, come è stato esposto in narrativa, la pronuncia
di condanna emessa dal primo giudice a favore dei lavoratori
e a carico della società I. s.p.a. è stata
travolta dalla decisione, non impugnata da chi ne aveva
interesse, con la quale il Tribunale ha dichiarata l'improcedibilità
della domanda proposta dai lavoratori "nei confronti
del fallimento". E, anche se si ritenesse il contrario,
la conclusione non potrebbe essere diversa, dal momento
che, essendo stata la pronuncia dichiarativa di fallimento
della società I. s.p.a. emanata, come è pacifico,
soltanto dopo che i lavoratori avevano esercitato contro
il Ministero l'azione prevista dall'art. 1675 c.c., la priorità
della proposizione di tale azione, come è stato spiegato
nella trattazione del primo motivo, aveva impedito al fallimento
di acquisire all'attivo le somme di danaro di cui si discute.
Va, da ultimo, esaminato il secondo motivo (indicato con
i numeri 3 e 4) dell'impugnazione proposta dal Ministero
delle Finanze, con il quale quest'ultimo, nel dedurre la
violazione e la falsa applicazione dell'art. 1676 c.c. e
il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo
comma n. 3 e 5, c.p.c.), sostiene:
a) che le somme sottoposte a sequestro dai lavoratori attenevano
non già ad un contratto di appalto "validamente
efficace fra le parti", ma "alla esecuzione di
una attività di servizio di pulizia di locali, svolta
solo in via de facto", non essendo mai "intervenuto
un atto di approvazione dello schema di contratto"
né risultando che fosse stato emanato un atto di
riconoscimento di spesa; b) che, d'altra parte, anche a
ritenere che un contratto fosse stato stipulato, il credito
della società appaltatrice non era né certo
né liquido né esigibile, dato che la procedura
contabile non aveva esaurito il suo iter attraverso la fase
dell'impegno di spesa, della liquidazione e dell'ordinazione
del pagamento e dato che l'opera svolta non era stata sottoposta,
ai sensi dell'art. 351 della legge n. 2248 all. F, a collaudo;
c) che da parte dell'amministrazione finanziaria accorreva
effettuare l'accertamento "di eventuali partite di
controcrediti, come, del resto, era stato fatto presente
al Tribunale nella memoria difensiva del 24 novembre 1998,
con la conseguenza che errata è la pronuncia con
la quale è stata dichiarata l'inammissibilità
delta eccezione di compensazione in quanto irritualmente
dedotta, anche perché l'eccezione in questione doveva
ritenersi implicitamente compresa nella eccepita inammissibilità
di qualsiasi statuizione di condanna senza il necessario
riconoscimento del debito nella competente sede amministrativa".
Anche queste censure sono infondate.
Quanto alla prima, è a dirsi che il ricorrente, dopo
avere (implicitamente) dato atto che il contratto di appalto
avente per oggetto il servizio di pulizia dei locali del
CESID era stato stipulato fra le parti, nemmeno indica per
quale ragione la pattuizione sarebbe rimasta priva di effetti
(dato che solamente accenna, in modo del tutto generico,
alla necessità di un provvedimento di. approvazione,
senza peraltro di tale atto specificare la provenienza e,
soprattutto, i tempi). Su questo punto della controversia,
d'altra parte, sussiste l'accertamento compiuto dal Tribunale,
il quale, senza adeguata smentita (mediante l'allegazione,
in concreto, di elementi probatori asseritamente non esaminati
nella sentenza), ha osservato che "la prova della sottoscrizione
e dell'esistenza di un regolare contratto di appalta l'ha
fornita lo stessa Ministero, che ha allegata al proprio
fascicolo due contratti, di cui il secondo integrativo".
Riguardo alla seconda censura, poi, va richiamato quanto
è stato esposto da questa Corte sia nella (non recente)
sentenza n. 3870 del 19 ottobre 1954, sia nella più
vicina sentenza n. 4051 del 10 luglio 1984 (già più
volte indicata).
Nella prima di tali sentenze é stato affermato che
l'art. 1676 c.c. trova applicazione anche in relazione agli
appalti regolati dalla l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F sui
lavori pubblici, col solo limite prevista dall'art. 351
di tale legge, dato che l'azione diretta degli ausiliari
dell'appaltatore contro la pubblica amministrazione non
può essere esercitata durante l'esecuzione delle
opere appaltate.
In applicazione di questo principio, quindi, si deve ritenere
l'ammissibilità dell'azione promossa dai lavoratori
nel presente giudizio, giacché, posto che l'appalto
del servizio di pulizia nei locali del CESID era stato compiutamente
eseguito, come ha accertato il Tribunale, il ricorrente
non ha investito con una apposita censura l'assunto, contenuto
nella sentenza impugnata, secondo cui, attesa la natura
del servizio appaltato alla società I. s.p.a., l'attività
di collaudo non doveva essere espletata.
Nella seconda sentenza è stato precisato che, essendo
le norme dettate dal codice civile in tema di appalto applicabili,
salvo che non sia espressamente previsto il contrario, anche
alle convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni,
l'importanza che la norma contenuta nell'art. 1676 c.c.
ha in materia di tutela dei lavoratori trova puntuale riscontro
- anche negli appalti per opere eseguite o per servizi.
svolti, per conto di una pubblica amministrazione - nell'art.
357 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, la quale espressamente
stabilisce che l'amministrazione può "pagare
direttamente la mercede giornaliera degli operai" dell'impresa
appaltatrice, non corrisposta alle previste scadenze; ed
è stato aggiunto che l'art. 351 della medesima legge,
che limita la possibilità del sequestro "sul
prezzo di appalto", non può estendere il suo
campo di applicazione all'azione diretta, contemplata dal
suddetto art. 1676 c.c., giacché la norma, unitamente
a quella di cui all'art. 357, sopra indicata, "manifesta,
al contrario, la configurabilità di rapporti diretti
tra gli ausiliari dell'appaltatore e l'ente committente".
Considerazione, codesta, che nel caso in esame deve essere
recepita per ritenere che, propria per la natura dell'azione
e per la finalità che la stessa persegue, non passa
trovare spazia la normativa relativa alla osservanza delle
norme sulla contabilità.
Della terza censura, infine, va rilevata l'estrema genericità,
perché non viene nemmeno chiarito se fra le parti
fossero esistenti partite di dare ed avere inerenti al medesimo
rapporto o contrapposti crediti relativi a rapporti diversi
con la conseguenza che ora non può essere sottoposta
a sindacato l'affermazione del Tribunale secondo cui l'eccezione
di compensazione non poteva essere esaminata nel merito
per non essere stata dedotta, ai sensi degli artt. 1242,
primo comma, c.c. e 416 c.p.c., nella memoria difensiva
del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 25 maggio 1995 n.
5757).
Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, poiché
la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure dedotte,
i ricorsi proposti dal fallimento della società I.
s.p.a. e dal Ministero delle Finanze debbono essere rigettati
e i ricorrenti, rimasti soccombenti, debbono essere condannati
a pagare, in solido, alle controricorrenti le spese del
presente giudizio. Non deve essere emesso alcun provvedimento
sulle spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna, in solido,
i ricorrenti a pagare alle controricorrenti le spese del
giudizio di cassazione, che liquida in complessive Lire
43.000 oltre a Lire 10.000.000 (diecimilioni) per onorari.
Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000