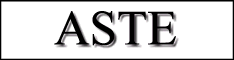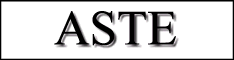Corte
Costituzionale, ordinanza 7 novembre 2001, n. 361, Inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art.
10 L.F. nella parte in cui esonera dal fallimento l’imprenditore
individuale già iscritto nel Registro delle Imprese,
il quale ha effettivamente cessato l’esercizio dell’impresa
da un anno, a prescindere dall’opponibilità
del fatto ai terzi secondo il meccanismo degli artt. 2193-21963
c.c
ORDINANZA N.361
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Fernando SANTOSUOSSO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa),
promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 2000 dal Tribunale
di Monza nel procedimento civile vertente tra Gollinucci
Luigi e il Fallimento Gollinucci Luigi ed altra, iscritta
al n. 102 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell’ano 2001.
Udito
nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il Giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto
che il Tribunale di Monza, con ordinanza emessa il 2 novembre
2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa),
«nella parte in cui tale norma esonera dal fallimento
l’imprenditore individuale già iscritto nel
Registro delle Imprese, il quale ha effettivamente cessato
l’esercizio dell’impresa da un anno, a prescindere
dall’opponibilità del fatto ai terzi secondo
il meccanismo degli artt. 2193-21963 c.c.»;
che
il Tribunale rimettente muove dalla premessa secondo cui,
alla stregua del diritto vivente, il termine di un anno
previsto dall’art. 10 della legge fallimentare per
l’assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore
che abbia cessato l’attività imprenditoriale
decorre dalla cessazione di fatto dell’impresa, dovendosi
attribuire alle risultanze dei registri pubblici –
ivi compreso il registro delle imprese, istituito con legge
29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura) - un valore
soltanto indiziario dell’effettiva interruzione dell’attività;
che
siffatta disciplina risulterebbe, tuttavia, sostanzialmente
diversa da quella prescritta per l’imprenditore societario
"cessato" nonché per il socio illimitatamente
responsabile che abbia dismesso la propria partecipazione
in società;
che,
per quanto riguarda l’imprenditore collettivo, infatti,
il termine di cui all’art. 10 della legge fallimentare
decorre espressamente, a seguito della sentenza di questa
Corte n. 319 del 2000, dalla cancellazione della società
dal registro delle imprese, mentre, per quanto riguarda
gli ex soci illimitatamente responsabili, pur in difetto
di un analogo dato testuale, nessun ostacolo si opporrebbe
ad un’interpretazione della citata sentenza n. 319
del 2000 nel senso che il termine di un anno dalla perdita
della responsabilità illimitata, entro il quale può
essere dichiarato il fallimento di costoro, in estensione
di quello della società, decorra soltanto dalla data
della relativa pubblicità;
che
la rilevata disparità di trattamento tra imprenditori
individuali e collettivi si tradurrebbe, secondo il rimettente,
in una disparità di trattamento anche tra creditori
i quali sarebbero maggiormente tutelati, sotto il profilo
dell’affidamento, qualora contrattino con una società
piuttosto che con un imprenditore individuale, con l’ulteriore
conseguenza di rendere maggiormente oneroso il ricorso al
credito per gli imprenditori individuali, proprio in ragione
del rischio che costoro possano sottrarsi all’esecuzione
collettiva «attraverso un semplice comportamento omissivo,
non ostensibile ai terzi»;
che
il legislatore, nella sua discrezionalità, potrebbe,
d’altro canto, fissare limiti temporali differenti,
dopo la cessazione dell’impresa, per l’assoggettamento
al fallimento dell’imprenditore individuale e di quello
collettivo (o del socio illimitatamente responsabile), ma
non anche individuare in maniera difforme l’evento
costituente il dies a quo dei rispettivi termini;
che
la denunciata disparità di trattamento potrebbe essere
eliminata solamente rendendo omogenee le due discipline
e quindi «assoggettando al vincolo della pubblicazione
per conseguire l’opponibilità quanto alla decorrenza
dell’anno anche la cessazione dell’impresa individuale»;
che
l’enfatizzazione della natura "materiale"
della cessazione dell’attività imprenditoriale
individuale si rivelerebbe in definitiva coerente con una
concezione arcaica dell’impresa, rispondente al tipo
della fabbrica ottocentesca, ma non più adeguata
all’attuale sistema economico e risulterebbe, pertanto,
in contrasto anche con il principio di ragionevolezza;
che
conclusivamente la norma, come risultante dal diritto vivente,
contrasterebbe non solo con l’art. 3 Cost., sotto il
profilo della violazione sia del principio di eguaglianza
che del canone di ragionevolezza, ma anche con l’art.
24 Cost., «nella misura in cui assoggetterebbe la
tutela giurisdizionale, sia pur esecutiva "speciale",
del credito ad un ostacolo non controllabile né percepibile
dal titolare della situazione soggettiva pregiudicata»;
che
risulterebbe infine leso anche l’art. 97 Cost., in
quanto l’indicata normativa pregiudicherebbe il buon
funzionamento dell’amministrazione della giustizia.
Considerato
che il rimettente censura l’art. 10 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell’amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), con riferimento agli
artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nell’interpretazione,
evidentemente non condivisa ma assunta come diritto vivente,
secondo la quale il termine di un anno ivi previsto per
l’assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore
che abbia cessato l’attività imprenditoriale
decorre in ogni caso dalla cessazione di fatto dell’impresa,
dovendosi attribuire alle risultanze dei registri pubblici
– e dunque anche a quelle del registro delle imprese,
previsto dall’art. 2188 del codice civile ed effettivamente
istituito con la legge n. 580 del 1993 - un valore soltanto
indiziario dell’effettiva interruzione dell’attività;
che
siffatto diritto vivente – la cui esistenza è
apoditticamente affermata – non trova tuttavia riscontro
alcuno nella giurisprudenza di legittimità successiva
all’entrata in vigore della citata legge n. 580 del
1993, per quanto specificamente riguarda l’asserita
irrilevanza rispetto ai terzi, ai fini dell’applicazione
dell’art. 10 della legge fallimentare, della iscrizione
nel registro delle imprese della cessazione dell’impresa,
iscrizione prevista come obbligatoria dall’art. 2196,
terzo comma, del codice civile, per gli effetti di cui all’art.
2193 dello stesso codice;
che
del tutto estranee alla problematica in questione sono infatti,
con ogni evidenza, le pronunce riguardanti il valore meramente
indiziario delle risultanze di pubblici registri diversi
dal registro delle imprese;
che
d’altro canto l’affermazione – costante nella
giurisprudenza, anche recente, della Cassazione – secondo
cui «la cessazione dell’attività di impresa,
ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale
può essere dichiarato il fallimento dell’imprenditore
(art. 10 l. fall.), presuppone che nel detto periodo non
vengano compiute operazioni intrinsecamente identiche a
quelle poste in essere nell’esercizio dell’impresa»
(Cass. 4 settembre 1998, n. 8781), non è affatto
incompatibile con il riconoscimento di una piena efficacia
dichiarativa alla iscrizione della cessazione dell’impresa
nell’apposito registro;
che
è infatti del tutto coerente con i principi della
pubblicità dichiarativa la possibilità per
i terzi di provare la non veridicità del fatto iscritto
e, dunque, in ipotesi, di dimostrare il compimento di atti
di esercizio dell’impresa successivamente alla iscrizione
della sua cessazione;
che
l’interpretazione che il rimettente ritiene lesiva
di principi costituzionali è pertanto erroneamente
qualificata in termini di diritto vivente e non è
sicuramente l’unica compatibile con il tenore della
norma;
che
la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative
per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell’amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
di Monza con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
F.to:
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Annibale
MARINI, Redattore
Maria
Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 7 novembre 2001.
Il
Cancelliere
F.to:
FRUSCELLA